.jpg) Mandrie in alpeggio - Foto di jacqueline macou da Pixabay
Mandrie in alpeggio - Foto di jacqueline macou da Pixabay Malga - Foto di grio75 da Pixabay
Malga - Foto di grio75 da Pixabay Capre in alpeggio - Foto di Ercole Sartori da Pixabay
Capre in alpeggio - Foto di Ercole Sartori da Pixabay Foto di Francesco Foti da Pixabay
Foto di Francesco Foti da Pixabay Mucche in alpeggio - Foto di Christel da Pixabay
Mucche in alpeggio - Foto di Christel da Pixabay Foto di Jörg Vieli da Pixabay
Foto di Jörg Vieli da Pixabay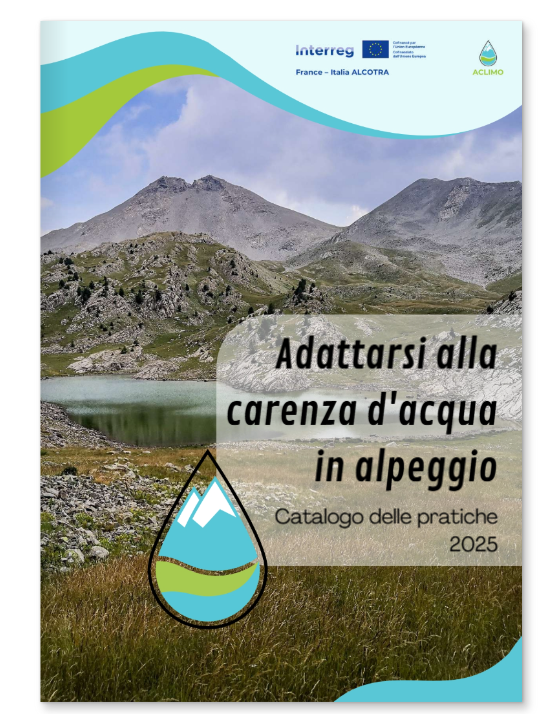 Il catalogo ACLIMO
Il catalogo ACLIMOLa tradizione dell’alpeggio affonda le sue radici in tempi molto lontani. Fin dall’età della pietra, l’uomo ha infatti identificato i verdi prati in quota come luogo ideale in cui portare il bestiame nella calda stagione estiva. Nel corso dei secoli, quella che inizialmente rappresentava una pratica saltuaria, si è consolidata, al punto da arrivare a parlare di stagione dell'alpeggio.
Un periodo dell’anno, orientativamente esteso da fine primavera a inizio autunno (maggio - ottobre), con differenze locali e annuali, legate alle variabilità del clima, in cui mandrie di bovini e greggi di ovini vengono trasferiti dalle stalle di fondovalle ai pascoli in quota, dove possono giovare dell’abbondante erba fresca. Anche gli allevatori trascorrono la stagione tra i pascoli, conducendo le loro giornate in strutture, dette malghe o alpeggi, all’interno delle quali vengono prodotti formaggi, burro e altri latticini.
Sulla base della lunga storia di questa tradizione, la Svizzera ha avanzato nel 2022 la candidatura della stagione alpestre per l’inserimento nella Lista rappresentativa del patrimonio culturale immateriale dell’umanità UNESCO. Obiettivo raggiunto un anno più tardi, nel dicembre 2023.
Un patrimonio immateriale da preservare per il futuro, un futuro caratterizzato da un ingente problema: la progressiva riduzione delle risorse idriche in quota. Il destino degli alpeggi è assimilabile a quello dei rifugi alpini. In entrambi i casi si tratta di strutture in quota che dipendono, per il loro approvvigionamento idrico, essenzialmente dalle disponibilità locali di acqua. Senza acqua è difficile, se non impossibile, restare in quota. Cosa si può fare per salvare gli alpeggi da un futuro incerto?
Come salvare gli alpeggi nell'era della crisi idrica
A cercare di fornire una risposta pratica al problema è il progetto ACLIMO, iniziativa di cooperazione transfrontaliera, che vede coinvolti parchi naturali italiani e francesi. Ente capofila del progetto è il Parc National du Mercantour. Tra i beneficiari italiani vi sono le aree protette delle Alpi Marittime e delle Alpi Cozie, il Parco Nazionale del Gran Paradiso e il Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri.
Avviato nel 2023 con il finanziamento del programma Interreg-Alcotra, ACLIMO ha l'obiettivo di supportare le comunità alpine nell’affrontare le sfide del cambiamento climatico, con particolare riferimento alla progressiva riduzione delle risorse idriche.
Di recente, nell’ambito del progetto transfrontaliero, è stato realizzato un “Catalogo delle pratiche di adattamento alla carenza idrica negli alpeggi”. Una pubblicazione che non nasce allo scopo di fornire la soluzione perfetta al problema, ma con l’intento di fungere da strumento utile ai decisori.
Fornisce infatti ai gestori dei parchi una visione d’insieme delle potenziali soluzioni da adottare per favorire l’adattamento della pratica dell’alpeggio alla ridotta disponibilità di acqua, e il relativo impatto. Nel dettaglio, vengono presentati sia adattamenti della gestione pastorale, quali la rimodulazione del calendario o della dimensione delle mandrie o delle greggi, sia interventi tecnici atti a favorire la raccolta e lo stoccaggio delle acque. Come evidenziato nella introduzione al catalogo “ogni caso è unico e richiede una riflessione individuale”. La pubblicazione realizzata nel mese di luglio è inoltre da considerarsi una prima versione, che potrà essere ampliata in futuro grazie a nuovi contributi e sperimentazioni sul campo.
Per consultare e scaricare il catalogo, si consiglia di visitare il sito ufficiale delle Aree Protette delle Alpi Marittime.