 Come fa un lago a riflettere l'immagine della montagna? Dipende da molti fattori. E così per uno scrittore. @ Pixabay
Come fa un lago a riflettere l'immagine della montagna? Dipende da molti fattori. E così per uno scrittore. @ PixabayNon è solo la nostalgia delle amatissime Dolomiti Bellunesi a comparire fra le pagine di Barnabo delle montagne, il primo romanzo di Dino Buzzati, o un approccio borghese alla montagna, che quando esce il libro, nel 1933, si sta facendo strada nella società. C’è anche, più sottile, tutto lo smarrimento di quell’epoca provocato dalla constatazione che una certa conoscenza materiale delle “cose” si sta perdendo, e che la società è sempre più un insieme di individui, a sfavore del concetto di collettività. Un “disincantamento” così profondo da spingere l’autore a scegliere la forma narrativa della favola: dove non è la fuga della realtà a comandare, bensì la trasfigurazione fantastica dei suoi timori (timori non diversi da quelli che viviamo oggi anche noi, alle prese con l’avvento dirompente dell’intelligenza artificiale e lasciati soli in rapporti umani troppo spesso mediati dal mezzo tecnologico). E dove i paesaggi dolomitici vengono descritti di conseguenza senza troppi approfondimenti né particolari concreti.
Non è una novità che lo scrittore sia strettamente collegato al contesto storico e sociale in cui è calato: lo scrisse Antonio Gramsci parlando di “intellettuali organici”. Per lui non esiste l’autorialità pura, completamente indifferente al luogo in cui è nata, al tempo in cui sta vivendo, ai fatti a cui assiste, alle condizioni in cui vive. Un approccio lontanissimo dagli esteti ottocenteschi che predicavano “l’arte per l’arte”, affidando allo scrittore e più in generale all’intellettuale un ruolo distaccato rispetto alla realtà.
Ma cosa c’entra questo con la montagna? Ce lo spiega Silvia Segalla nell’approfondito saggio di critica letteraria In montagna. Paesaggi letterari e passaggi d’epoca (pp. 136, 12 euro, Rosenberg&Sellier 2025), che analizza nello specifico come il contesto storico e sociale influisca nel modo di raccontare e descrivere il paesaggio, in particolar modo la montagna. Lo fa attraverso tre casi letterari: oltre a Barnabo delle montagne, I Brusaz di Giovanna Zangrandi e Le otto montagne di Paolo Cognetti, di cui vengono descritti trama, personaggi, ambientazione.
L’analisi di questi tre romanzi infatti non serve solo a esplorare il tema in sé, ma soprattutto a capire come il racconto della montagna cambi nel tempo e si intrecci con idee e ideologie diverse. Ogni libro infatti riflette un diverso modo di concepire la relazione tra l’uomo e la montagna: se Buzzati la vede come un mondo quasi perfettamente autosufficiente, Zangrandi la lega alle dinamiche del lavoro e Cognetti la mette in contrasto con la pianura e la modernità. Tutti e tre tuttavia scelgono di non citare luoghi reali, seppure si capisca dalle descrizioni a quali geografie facciano riferimento.
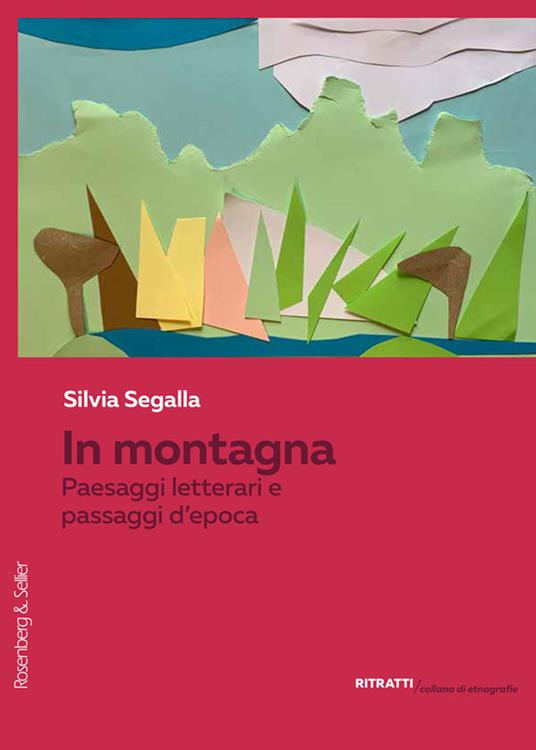
Di Buzzati abbiamo detto. Zangrandi fu staffetta partigiana, dopo che aveva scelto di andare a vivere in Cadore, lei che era nata in pianura, a Galliera, nel bolognese. Forse proprio il fatto che sulle Dolomiti non ci si era ritrovata per nascita, ma per scelta rende la sua scrittura molto attenta ai luoghi, alle comunità che li popolano e ai mestieri che vi svolgono, alla loro cultura materiale. Dei tre, infatti, pur non descrivendo paesi e cime esistenti, è lei quella più aderente alla realtà della montagna in cui ambienta i suoi libri, come appunto I Brusaz, l’opera prima. Quello stile di vita era il suo, anche fuori dalla letteratura, per questo si riflette fra le pagine.
È naturalmente Cognetti quello più vicino a noi: il libro esce, con enorme successo testimoniato anche dalle numerose traduzioni, in un’epoca in cui la montagna, dove il fenomeno dello spopolamento è ormai conclamato, diventa meta turistica e sportiva di gran successo, apprezzata per la sua dimensione naturalistica. È l’approccio tutto urbano, sottolinea l’autrice, di chi la montagna la vive solo nella sua dimensione vacanziera, lontano, addirittura estraneo a quanti in montagna vivono e lavorano ogni giorno, lottando proprio con e a volte contro quella natura tanto ricercata dagli stressati cittadini.
Cognetti è calato nel suo tempo e di questo parla, nella storia di Bruno e Pietro, come ha poi ben reso anche la versione cinematografica uscita molto dopo: nella sua visione della montagna si riflettono le polarizzazioni tutte contemporanee fra natura e umanità, antropico e selvaggio, città e montagna, per fare alcuni esempi, contrasti inconciliabili che dominano un presente angosciato dalla crisi climatica.
Se fossimo noi, ora, quasi 10 anni dopo Le otto montagne (uscito a fine 2016), a dover scrivere un romanzo ambientato in montagna, non potremmo che proseguire sulla scorta di Cognetti, perché tutti i temi posti nel suo romanzo sono ancora sul piatto. Se va bene, ne abbiamo forse più consapevolezza.