 Luca Gibello ospite di Letteraltura 2025, con Andrea Greci. Foto Pamela Lainati
Luca Gibello ospite di Letteraltura 2025, con Andrea Greci. Foto Pamela Lainati Bivacco Pasqualetti. Foto tratta dal libro, di Grzegorz Grodzicki e Adele Muscolino.
Bivacco Pasqualetti. Foto tratta dal libro, di Grzegorz Grodzicki e Adele Muscolino.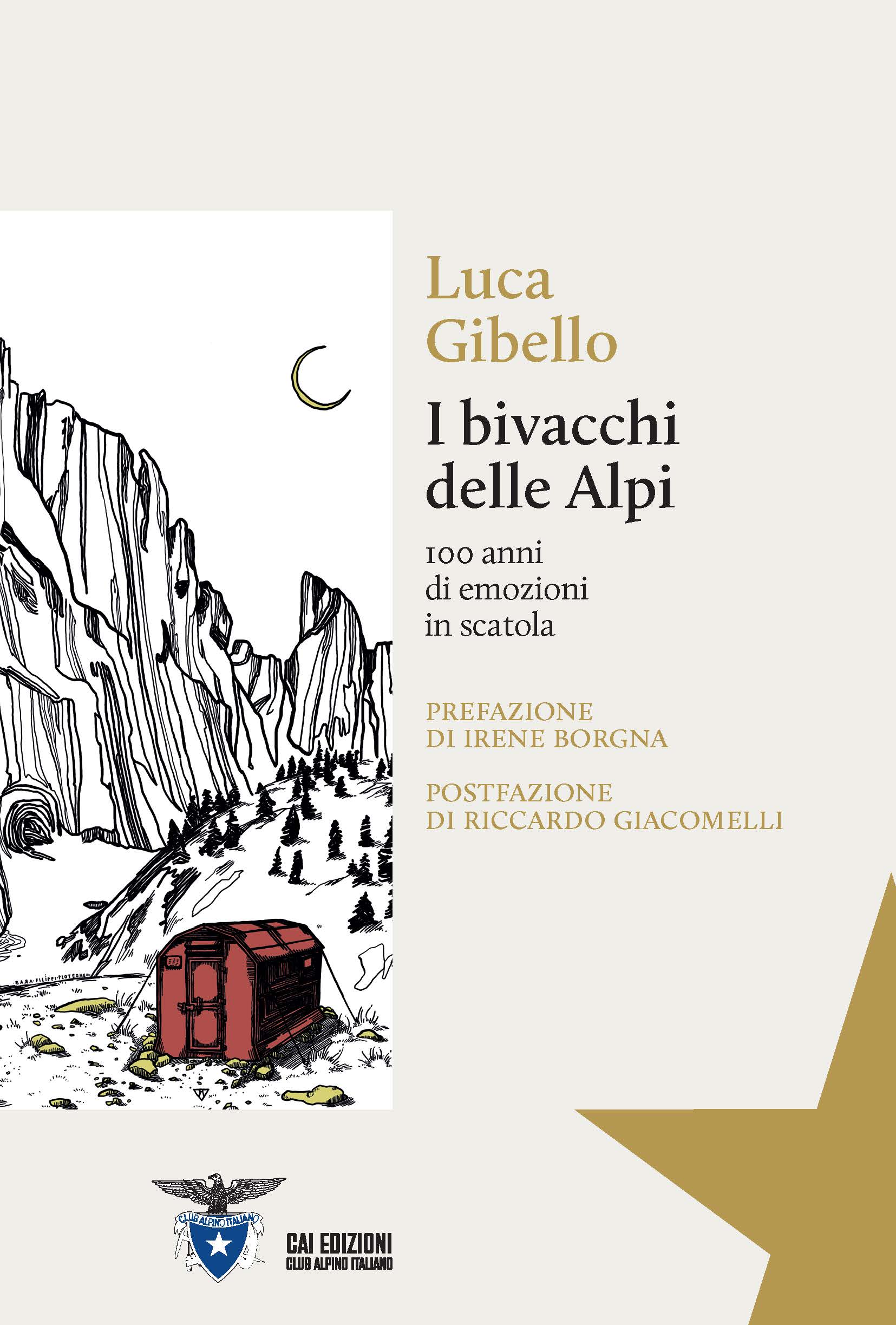 La copertina del libro.
La copertina del libro.Si celebra quest’anno il primo secolo di vita del bivacco fisso, un’invenzione tutta italiana che si deve agli Accademici del CAI, nel 1925: per ripercorrere questa storia Luca Gibello ha condotto un’approfondita ricerca che oggi ha preso la forma di un libro intitolato I bivacchi delle Alpi. 100 anni di emozioni in scatola (pp. 256, 26 euro, CAI Edizioni), che gode della prefazione di Irene Borgna dal curioso titolo di “Bivaccosofia” e della postfazione di Riccardo Giacomelli, presidente della Struttura Operativa del CAI che si occupa di Rifugi e Opere Alpine.
Gibello ha spulciato attraverso centinaia di vecchie riviste del CAI, disponibili online in forma digitalizzata, e le fotografie conservate nel Centro Documentazione della Biblioteca Nazionale del CAI a Torino. Le circa 200 immagini a colori presenti nel libro danno anche visivamente l’idea della vastità e della bellezza dell’argomento, affrontato con tono divulgativo e in relazione a diversi temi: quello prettamente architettonico e quello abitativo, ma anche quello legato all’evoluzione dell’alpinismo che ne modifica il ruolo, fino all’analisi delle nuove tendenze sociali, che con la frequentazione consapevole della montagna non hanno nulla a che vedere.
Ne emerge il “ritratto” del bivacco non solo come riparo necessario, ma anche luogo di memoria, punto di osservazione di panorami unici e occasione per esperienze straordinarie. “Per formazione, dai tempi del dottorato al Politecnico di Torino in Storia dell’architettura, ho affrontato questa disciplina con uno sguardo sociologico – dichiara Gibello –, imparando a leggerla non solo dal punto di vista delle forme e dei materiali, ma anche come espressione di valori civili, politici ed economici della società”.
Luca, come nasce il bivacco, invenzione tutta italiana degli Accademici del CAI?
Il bivacco fu un’invenzione assoluta, nata dalla necessità di avere un riparo minimo, più che essenziale. Non a caso fu concepito dagli Accademici del CAI, ovvero i “senza guida”, persone che in montagna rifiutavano convintamente ogni tipo di agevolazione, che fossero i servizi delle guide alpine o il “comfort” dei rifugi. Non bisogna però dimenticare che all’epoca era da poco finita la Prima guerra mondiale: durante la Guerra Bianca, combattuta sulle montagne, disporre di un riparo minimo era stato vitale per non soccombere alla durezza dell’ambiente. Le baracche modello Damioli, dal nome dell’ingegnere che aveva brevettato queste “scatole in lamiera ondulata”, hanno di certo costituito un precedente, se ne può ancora osservare una al Museo della Guerra Bianca di Temù, in Adamello. La struttura era simile: una nervatura lignea rivestita da lastre di metallo.
Nel libro compare una pubblicità del 1938 in cui il bivacco viene paragonato a una cuccia per cani…
Il primo modello di bivacco si deve ai fratelli Ravelli di Torino (tra cui Francesco li ideava e Zenone li montava) e alla lunga si è rivelato il più longevo: dopo un secolo ne sono ancora in uso ben quattro, di cui il primo in assoluto, quello dedicato ad Alfonso Hess, al Colle d’Estellette (2958 metri), poi Balestreri, Brenva e Craveri. Aveva dimensioni minime: in due metri per due ci stavano quattro o addirittura cinque persone. Veniva associato a una cuccia per cani perché si entrava rasoterra, come attraverso la porticina di un gatto, dentro per terra c’era una stuoia di cocco, e vista la ristrettezza dello spazio un cartello indicava dove posizionare i piedi, come si osserva da alcune bellissime fotografie conservate al Centro Documentazione della Biblioteca Nazionale del CAI. I primi dieci bivacchi uscirono tutti dall’officina meccanica dei Ravelli di Torino, che poi si trasformò in negozio di abbigliamento e attrezzatura alpinistica, diventando una sorta di “Cenacolo” del gotha alpinistico torinese, fino ai primi anni ’90.
Paragoni il bivacco a una “navicella spaziale aliena”: non si può non ricordare Lino Lacedelli quando affermò che salire sul K2 fu “come andare sulla Luna”. L’allunaggio del 1969 ebbe un fortissimo impatto sull’estetica collettiva disegnando nuove frontiere per il destino umano, quindi la tua non è solo una metafora letteraria…
Al modello Ravelli subentra quello ideato da Giulio Apollonio che riesce, con un’opera di ingegneria perfetta, a portare le dimensioni del bivacco a 6 metri quadrati per 9 persone. Ma dopo la missione spaziale del ‘69 il bivacco diventa la cosa più simile a un modulo lunare, collocato però in un luogo decisamente più accessibile, per quanto remoto. Si pensi al Bivacco Ferrario in Grignetta o allo Stockhorn in Svizzera, piccole scatolette dalle forme geometriche e le zampette di sostegno. Anche i materiali da costruzione furono mutuati dell’ingegneria aerospaziale, la scocca fu realizzata in poliestere e vennero usati altri materiali leggeri e durevoli di sintesi.
E arriviamo all’odierno “glamping” (neologismo che fonde “camping” e “glamour”, forma di turismo che coniuga il desiderio di stare in natura senza rinunciare al lusso) e al rischio che qualcuno interpreti il bivacco come fonte di adrenalina a costo zero, per quanto resti per definizione una struttura impervia e di accesso alpinistico.
Impervia sì, perché le varie normative regionali, con qualche variante e ulteriori specifiche, stabiliscono che si parla di bivacco solo per strutture incustodite sopra i duemila metri. Mi stupisco, ma ormai sempre meno purtroppo, di trovare online pezzi del tipo “I dieci luoghi più straordinari dove dormire”, che mettono sullo stesso piano la yurta nel deserto mongolo con la cabin wild in Norvegia a precipizio su un fiordo, il Rifugio Carota sulle Dolomiti Bellunesi e… il Bivacco Gervasutti! Senza naturalmente specificare che al Gervasutti ci possono andare solo persone allenate e preparate. È un grave errore da parte di chi gestisce questo genere di comunicazione, e pone un problema in termini di sicurezza, per ovvi motivi.
Scrivi che sull’intero arco alpino si stima la presenza di quasi 350 bivacchi, ma ben 250 sul versante italiano. Se si capisce come mai ce ne siano pochi sugli Appennini o in Paesi con poche vette prominenti, stupisce soprattutto il confronto con la Svizzera e con la Francia. Il bivacco resta insomma una prerogativa italiana.
Gli svizzeri di bivacchi ne hanno circa 25, i francesi tre, perché in entrambi i casi si punta di più sul rifugio, inteso eventualmente come struttura incustodita. In Slovenia sono una ventina, in Austria circa il doppio. I francesi degli anni ’20 e ’30 criticavano i nostri bivacchi perché secondo loro interrompevano la sequenza logica della cresta e agevolavano troppo la salita. In ogni caso 250 bivacchi sono davvero molti, se si pensa che l’alpinismo di oggi viene praticato in velocità.
Si genera un paradosso: il bivacco che nasce per i senza guida finisce per essere usato oggi soprattutto dai clienti con le guide.
Sono state proprio le guide alpine, dagli anni ’90 in poi, a spingere perché se ne costruissero di più, rispondendo alle richieste dei clienti. Pensiamo alla traversata delle Grandes Murailles a Valtournanche, punteggiata da 5-6 bivacchi. Oggi invece gli alpinisti prediligono la velocità, la leggerezza e di conseguenza la sicurezza.
Nel 2022 una frana di sassi ha causato il crollo del bivacco al Colle della Fourche, nel Gruppo del Monte Bianco, l’anno dopo abbiamo perso il Meneghello in Valfurva, per il cedimento dello sperone su cui era appoggiato, forse dovuto all’erosione provocata dalla fusione del ghiacciaio. Anche i bivacchi risentono del cambiamento climatico.
I bivacchi sono più piccoli, non hanno fondamenta, sono ancorati alla roccia in uno spazio molto ristretto. Ma anche loro, come i rifugi, accusano le trasformazioni delle montagne e in particolare del permafrost, alcuni sono sotto monitoraggio, a partire dalla Capanna Margherita, che il CAI controlla attentamente, altri sembrano anche reggere ma per sicurezza sono dichiarati inagibili, come il Canzio alle Grandes Jorasses in Val Ferret. Altri si è preferito spostarli.
Hai salito tutti i quattromila delle Alpi, qual è il tuo bivacco preferito?
Per me il modello Apollonio, che si vede anche nell’illustrazione in copertina, resta un mito: non si può fare meglio di così in sei metri quadrati. L’esperienza che si prova lì dentro, al chiuso proprio come in una scatola di sardine, con il vento di bufera che sbatte fuori, è unica. Ero molto critico verso il Gervasutti, prima di andarci, ora lo apprezzo molto: la forma a cannocchiale a sezione ellittica e la posizione a sbalzo non sono solo una scelta estetica gratuita, ma sono funzionali a favorire lo scarico della neve in un punto dove slavina molto. Dalla foto a doppia pagina nel libro si capisce bene. E una doppia pagina l’ho voluta dedicare anche al Bivacco Pasqualetti in Valpelline, un nido d’aquila che tiene insieme la forma a capanna con l’idea archetipica dell’abitare estremo.
Prima dicevi che ami il modello Apollonio perché sa ottimizzare lo spazio più degli altri. E questo ci riporta a noi, oggi: perché facciamo così fatica a rinunciare al comfort e a godere dell’essenzialità almeno in montagna?
Per lo stesso motivo per cui oggi ci sembra impossibile che un tempo in una Cinquecento ci potessero stare cinque persone. Non ci vogliamo più adattare. Non rinunciamo più alla tecnologia. Personalmente, sono alla vecchia maniera, non ho nemmeno uno smartphone e quando vado in montagna non uso il gps, se sono in macchina tiro giù il finestrino e chiedo a qualcuno le indicazioni. Se giro per turismo, quindi per divertimento, accetto l’idea di perdermi. A mio modo cerco di resistere all’artificialità che ci sta prendendo tutti, alla necessità dilagante di protezioni di ogni genere, se non abbiamo dietro il cellulare siamo morti… Voglio provare a vivere ancora la montagna come uno spazio di esplorazione e avventura, di autodeterminazione, di rischio controllato e di meraviglia. Non possiamo sempre pensare di trovare la bellezza dove un dispositivo ce lo indica. La montagna non è una realtà aumentata dove a guidarci sono i Google Glass. Le mie esplorazioni partono dalle cartine geografiche: per me sono come dei libri, resto a guardarle per ore.