 Clauidio Smiraglia
Clauidio Smiraglia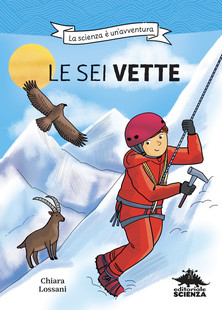 La copertina del libro.
La copertina del libro. La rettrice Alessandra Petrucci con Claudio Smiraglia. © Università degli Studi di Firenze
La rettrice Alessandra Petrucci con Claudio Smiraglia. © Università degli Studi di FirenzeNon avrebbe forse mai immaginato Claudio Smiraglia, glaciologo italiano di fama mondiale, che un giorno sarebbe diventato il protagonista di un romanzo per bambini: ci ha pensato Chiara Lossani, scrivendo Le sei vette (pp. 208, 14,90 euro, Editoriale Scienza 2025, dagli 8 anni). Una storia che ha il dono del ritmo, mescolando con maestria realtà e fantasia nel rispecchiare quasi fedelmente la vita e la carriera professionale di Smiraglia, in un riuscito incastro narrativo con temi importanti, trasmessi ai giovani lettori con semplicità e senza mai dare l’impressione che siano lì per forza, perché si deve: la passione come motore di un’intera vita, tanto da farne poi un lavoro, anche se inizia quando si è bambini, l’entusiasmo verso la conoscenza, il desiderio di incontrare altre culture, ma anche il cambiamento climatico e tutto ciò che comporta. Ne abbiamo parlato con Claudio Smiraglia, Professore ordinario di Geografia fisica all’Università degli Studi di Milano in pensione, con una laurea honoris causa in Scienze e Tecnologie Geologiche ricevuta nel 2023 dall’Università degli studi di Firenze, già Presidente del Comitato Glaciologico Italiano e del Comitato Scientifico del Club Alpino Italiano, con centinaia di pubblicazioni all’attivo, ma anche uomo di cultura, appassionato di letteratura e musica classica, di un’umanità pulsante, convinto che il futuro sia in mano ai giovani.
Professor Smiraglia, il libro è un omaggio a un’intera esistenza dedicata alla montagna. La ricorda ancora, l’emozione del primo incontro con un ghiacciaio che ha dato senso a tutta la sua vita, come si legge?
La ricerca scientifica è affascinante, soprattutto nel nostro campo, ma se non c’è emozione manca qualcosa. Io la provo ancora che esco in montagna. Mi ritengo estremamente fortunato, perché ho potuto abbinare una passione giovanile, scaturita in quel modo un po’ pittoresco che viene raccontato nel libro, con una professione. Fare un lavoro che ti entusiasma è la cosa più bella in assoluto.
Ha mantenuto il legame “affettivo” con la Sforzellina?
Sembra sciocco, ma negli ultimi anni con la Sforzellina, ma pure con gli altri ghiacciai e con gli alberi, ho iniziato a parlarci. Ormai non riesco più ad approfondire le tematiche scientifiche in senso stretto, che portano avanti i miei allievi, ma trovarmi in montagna per me rimane un’emozione. È da tempo che mi interrogo su quando arriverà il fatidico momento in cui non potrò più vedere le valli dall’alto, e pian piano ci stiamo avvicinando, anche se quest’estate un paio di vette di tremila metri le ho salite. Prendo consapevolezza dei miei limiti, al di là della tristezza che inevitabilmente questo genera.
Come vive questo limite personale?
Sfioro ormai gli 80 anni, i venti per quattro come dico, c’è un inevitabile decadimento fisiologico e psicologico. È in atto una “orogenesi rapidissima”, le montagne per me si stanno sollevando sempre di più: dove prima ci mettevo due ore adesso ne servono tre… In ambito universitario mi rendo conto che faccio più fatica a valutare gli studi dei miei allievi, sia a livello strumentale, che di conoscenze, perché queste si evolvono molto rapidamente. Se non altro continuo a scrivere articoli divulgativi, per il CAI e altre associazioni che mi danno un po’ di soddisfazione. Sto perdendo la memoria e non ho più voglia di girare il mondo.
Il titolo del libro in effetti richiama proprio la sua esperienza di studioso internazionale, raccontando le missioni scientifiche in Antartide, Kenya, Nepal…
Grazie alla mia professione ho viaggiato in termini che quel ragazzino protagonista del libro non avrebbe mai immaginato, e l’ho sempre fatto con due obiettivi: uno era la voglia di approfondire gli aspetti più scientifici relativi al glacialismo, alla geologia e altro. L’altro era soprattutto nei primi tempi la convinzione che girare il mondo ed entrare in contatto con altre culture, in Nepal, in Groenlandia, nelle Ande come in Africa, avrebbe giovato alla conoscenza dell’umanità, oltre che mia personale. Invece ho dovuto pian piano smorzare questo mio entusiasmo, vedendo crescere negli anni l’importanza dell’aspetto economico come motore primario di ogni azione e dei soldi nelle relazioni fra persone. Ma lei non dovrebbe scrivere queste cose, perché sono le riflessioni pessimistiche di un vecchio.
Lei ha avuto modo di visitare il Nepal prima che si affermasse il “turismo d’alta quota”, come lo chiama Messner. Come era allora da quelle parti?
Ho iniziato a frequentare il mondo delle grandi montagne al di fuori delle Alpi per vent’anni circa, fra gli anni ’70 e ’90. Ricordo la prima volta all’Everest: a Namche Bazar di notte c’era una sola luce in fondo dove funzionava il generatore. Quando sono tornato negli anni ’90 sembrava di stare a Chamonix. Ho visto la transizione dal piccolo turismo di lodge e alberghetti all’affollamento delle strade, che si riflette poi su quello che succede al campo base. Sulle Alpi il fenomeno è ancora più accentuato: ultimamente mi sono appassionato del tema dell’overtourism, ma questo ha scatenato in me molte domande.
Cosa la colpisce del fenomeno dell’overtourism?
Mi chiedo se sia stato giusto che per tutta la vita io, con le mie ricerche, nel tentativo per me positivo di aggiungere un piccolissimo tassello al mosaico gigantesco della conoscenza delle montagne, abbia spinto amici, studenti e colleghi ad andarci. Fino a pochi anni fa ogni domenica prendevo il treno e andavo in cerca delle zone più isolate. Ai giovani consiglio di conoscere certamente le aree più belle e acclamate, senza scordare che è in quelle meno frequentate che è più possibile raggiungere un rapporto più intimo con la montagna e con il nostro Pianeta in generale. Non sono mai stato in cima all’Everest, ma l’idea di mettermi in coda a ottomila metri mi sembra folle. Meglio quote minori ma meno gente, mi sembra questo l’orientamento dell’alpinismo degli ultimi anni, credo di altrettanta soddisfazione.
Dal libro traspare un rapporto alla pari con i suoi studenti e la voglia di trasmetter loro le sue conoscenze, non ha paura di perdere qualcosa?
La voglia di trasmettere agli altri mi ha guidato in tutta la mia carriera universitaria, perché nasce da lontano. La mia famiglia era economicamente piuttosto disagiata, dopo la fine della guerra si faceva davvero fatica a tirare avanti. Eppure i miei hanno deciso di farmi studiare, per fortuna ero figlio unico. Sono andato addirittura al liceo classico, all’esclusivo Beccaria di Milano, ma per la mia classe sociale non era consueto, e ho sofferto terribilmente le barriere sociali che esistevano, da un lato con i miei compagni, appartenenti alla borghesia milanese, dall’altro con i professori, molti erano veri e propri “baroni” del liceo. Quello di greco la prima volta che mi ha visto mi ha chiamato “pigmeo”, io ero bassino di statura, e ogni volta che entrava mi terrorizzava. Mi sono allora ripromesso che avrei fatto un lavoro che mi avrebbe consentito di insegnare in maniera diversa. Ho avuto la fortuna di incontrare all’università dei professori straordinari che hanno capito la mia passione per la montagna e mi hanno sempre sostenuto, anche se pure in quel contesto c’erano certi un po’ sussieguosi…
È vero che qualcuno all’inizio le disse di lasciar perdere, che la geografia non faceva per lei?
Vero, fu un assistente molto rigoroso! Fu a uno dei miei primi esami, quando ancora frequentavo Lettere Moderne, in pochi sanno che la mia prima laurea è stata quella, con una tesi sulla letteratura dell’alpinismo, da Guido Rey in poi: 110, ma non la lode, perché uno dei commissari si era risentito che non avessi parlato di Pio XI, un Papa alpinista che però non aveva scritto molto al proposito. Lui era un prete e io ero in Cattolica, e la cosa pesò. A Lettere il corso di Geografia era tenuto dal professor Angeloni, famoso studioso di ghiacciai, socio onorario del CAI: fu lui a capire la mia passione per la montagna indirizzandomi verso i geologi, persone straordinarie, come il professor Desio. Così è iniziata la seconda parte della mia istruzione.
Come ricorda Ardito Desio?
Innanzitutto voglio precisare che io non sono allievo di Desio, se no sarei molto più vecchio… Lo conoscevo di fama, dopo la salita del K2. E mi dispiace molto che i “profani” lo abbiano da allora associato solo alle polemiche derivate da quella vicenda, trascurando completamente il suo enorme contributo alla conoscenza della montagna. Era già in pensione quando negli anni ’70 ebbi l’occasione di conoscerlo, ma era ancora il “sovrano”: ero assistente alla cattedra di Geografia e contemporaneamente ero iscritto a Geologia, su suggerimento dei miei maestri in Cattolica. Quindi da un lato insegnavo, dall’altro imparavo, collaborando con gli allievi di Desio, fra cui Giuseppe Rombelli, per me il Professore con la P maiuscola, che mi ha sempre sostenuto e aiutato, e che mi mandò in Antartide. Poi un giorno Desio mi chiamò nel suo studio: entrai inchinandomi, perché sono basso ma Desio più di me, con lui bisognava sempre sedersi, e al suo fianco c’era un giovanotto di nome Agostino da Polenza. Mi disse: “Lei, Smiraglia, il prossimo giugno va in Karakorum al K2 a ripetere le misure che ho fatto io negli anni’20 e ’50, se lo ritiene”. Il nostro rapporto è cominciato così. I dati che ho raccolto gli sono piaciuti e li abbiamo pubblicati. Con Da Polenza sono poi andato anche all’Everest. Desio aveva la capacità di affrontare e risolvere ogni problema, adeguandosi al futuro, ma non tollerava rifiuti, nemmeno nei rapporti umani, quindi immagino le difficoltà degli alpinisti nel ’52. Aveva un carattere difficile: una volta mentre stavamo pranzando con Da Polenza in un ristorante, un cameriere gli portò un piatto che non gradì e se la prese con lui. Invece a me successe un episodio che non ho raccontato quasi a nessuno.
Quale episodio?
Negli anni ’90 ho scritto un libro, Guida ai ghiacciai e alla glaciologia, per Zanichelli, il primo manuale italiano di glaciologia divulgativa, e finora l’unico. Chiesi a Desio di presentarlo in Regione Lombardia, lui accettò, lo lesse, ma quando fu il momento di entrare nel Palazzo della Regione si arrabbiò moltissimo perché gli avevo dedicato solo quattro righe. Mi difesi argomentando che si trattava di un’opera divulgativa, ma non fu facile convincerlo a presentare il volume, come poi per fortuna fece. Questo era il suo carattere, ma senza di lui al K2 non ci saremmo andati.
La glaciologia si è molto evoluta, diventando sempre più multidisciplinare. Forse è per questo che è più difficile scriverne in maniera divulgativa?
Grazie alla mia formazione pluridisciplinare ho forse intuito per primo, negli ultimi dieci anni di attività, che i ghiacciai sono un sistema di cui stavamo cogliendo solo l’aspetto strettamente glaciologico. Invece è la testimonianza di un mondo molto più complesso e così ho iniziato a coinvolgere nelle ricerche anche i microbiologi. Abbiamo iniziato a campionare il terriccio sopra glaciale, trovando una grande quantità di vita. Il ghiacciaio non è una cosa sterile come spesso si dice, è ricchissimo di vita, solo che non la vediamo a occhio nudo, oppure ci fa schifo, come i vermi, i ragni, gli insetti. Poi abbiamo coinvolto i chimici per studiare la presenza di microplastiche. Forse questa complessità rende la glaciologia più difficile da divulgare, ma c’è anche un altro aspetto legato alla montagna.
Come cambia la montagna del glaciologo?
Fino a 10 anni fa salire su un ghiacciaio era semplice, l’ho fatto centinaia di volte portando decine di studenti, ai Forni non c’erano crepacci. Oggi anche solo mettere piede su un ghiacciaio è un’escursione che comporta pericoli. Si sale solo in cordata e con le Guide Alpine, bisogna sentirsela. Anche io del resto facevo un mio personale test ai giovani: li calavo dentro a un crepaccio per raccogliere dei ciottoli, se quando salivano erano bianchi gli consigliavo una tesi di laboratorio.
I ghiacciai scompariranno, le previsioni sono catastrofiche, scompariranno anche i glaciologi?
C’è un intero sistema solare zeppo di ghiacciai di ghiaccio da esplorare, tanti colleghi li stanno già studiando, ovviamente da immagini satellitari, e quindi ci sarà spazio per la glaciologia in futuro, non so ancora in che termini. Però mi permetto di fare una puntualizzazione a livello semantico. La scomparsa dei ghiacciai non è una previsione, è uno scenario: le previsioni possiamo farle per il tempo, perché si basano su modelli statistico-matematici che partono dai dati delle stazioni meteorologiche, con un orizzonte che va da domani a un mese. Nel caso dei ghiacciai, i tempi sono molto più lunghi e dobbiamo allora parlare di scenari risultanti da modelli statistico-matematici basati su quanto sappiamo oggi, che è sempre poco, dobbiamo restare umili. I ghiacciai potrebbero scomparire fra 50 o 100 anni se i modelli che usiamo oggi saranno ancora validi, se la temperatura continuerà a incrementare al ritmo di oggi a causa dell’attività antropica, se continueremo a scaricare gas serra nell’atmosfera come stiamo facendo… Dire che i ghiacciai scompariranno quindi non è un dato di fatto, ma uno scenario probabile, plausibile.
Questo ci lascia un margine di speranza?
Non lo so, sinceramente, non dipende tutto dall’uomo. Potrebbe accadere un grosso evento planetario, come eruzioni vulcaniche o bolidi extraterrestri che si schianteranno sulla Terra, sollevando una tale quantità di terriccio da bloccare le radiazioni solari, è già successo.
Però allora non ci sarà più nessun glaciologo a raccontarlo, vorremo salvare i ghiacciai, ma anche l’uomo…
E qui torniamo alle difficoltà di cui parlavamo di trovare un equilibrio rispetto alle esigenze di crescita globale. Il cosiddetto Homo sapiens sapiens, il “sapientissimo”, è semplicemente una delle tante specie, con istinti primordiali comuni: mangiare, riprodursi e avere un proprio spazio. E vediamo bene in questi tempi che ripercussioni possono avere queste tre leggi. Dipende tutto dai giovani, ora.