 Foto Cristina Restelli.
Foto Cristina Restelli.C’era una volta un ragazzo che si arrampicava sugli alberi per rubarne i frutti. I ragazzi erano tanti e i frutti saporiti. Poi, come i colori di una cartolina che sbiadisce attraverso il tempo, i ragazzi sono diventati pochi e i frutti senza sapore. Due fenomeni apparentemente lontani che invece si scoprono strettamente collegati leggendo le storie di “resistenza agricola” sulle montagne italiane al centro della nuova inchiesta di Giannandrea Mencini intitolata La battaglia dei semi. Come uscire dai monopoli alimentari (pp. 288, 18 euro, Kellerman 2025), con la prefazione della giornalista Elena Ciccarello, che da tempo si occupa di mafie e corruzione e oggi dirige la rivista “lavialibera”.
Seguendo la via dei semi e indagandone il sistema economico e amministrativo che ci sta dietro, il giornalista e scrittore veneziano spiega come il 63% del mercato delle sementi e il 75% di quello degli agrofarmaci siano monopolizzati da sole tre multinazionali, denunciando le gravi ripercussioni sociali, gli squilibri commerciali e la conseguente sottomissione di milioni di contadini e consumatori alle decisioni di pochi colossi. Un sistema che mette a repentaglio la sovranità alimentare dei Paesi e la biodiversità agricola, come evidenzia la testimonianza di Salvatore Ceccarelli, intervistato in premessa, già Ordinario di Genetica Agraria all’Università di Perugia, uno dei più grandi esperti al mondo nel campo della genetica applicata e di “agricoltura resiliente”. Per 30 anni ha vissuto in Siria con la moglie studiando per riportare in vita semi autoctoni migliorati per resistere alle nuove condizioni climatiche (e ai dilaganti Ogm che affamano i poveri contadini locali).
Fermandosi a quanto spiega Ceccarelli non ci sarebbe granché da rallegrarsi. La ricerca del malaffare condotta da Mencini diventa però anche ricerca del “buonaffare”: ed è così che l’autore è andato a caccia di storie che invece raccontano come sia possibile, pur con mille sforzi e un notevole rischio imprenditoriale, non piegarsi a questo sistema e anzi ridare vita a luoghi dove lo spopolamento da un lato ha causato il largo abbandono della natura circostante e dall’altro ha lasciato campo aperto all’agricoltura intensiva poco rispettosa della biodiversità locale, in un circolo vizioso in cui l’uno determina l’atro e viceversa. La ricerca si è concentrata sulle montagne italiane, dove già Mencini aveva denunciato la “mafia dei pascoli” e “il vizio delle monocolture sulle terre alte”, per citare le sue precedenti e pluripremiate opere, Pascoli di carta (2021) e Bioavversità (2023).
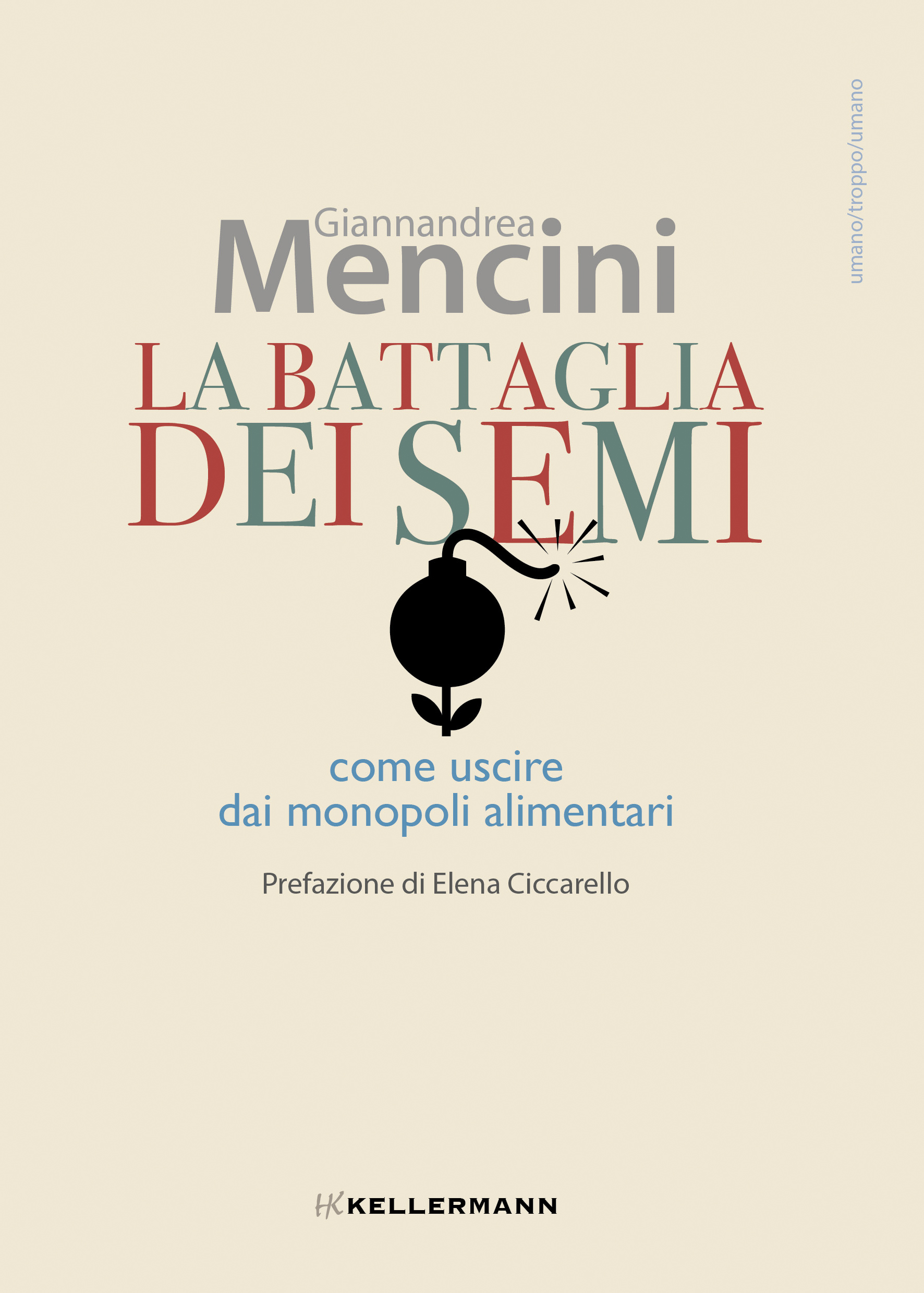 La copertina del libro.
La copertina del libro.Una parola bisogna spenderla sul modo in cui Mencini conduce le sue inchieste, ma basta riprendere quanto scrive Elena Ciccarello nella prefazione: è un approccio “spontaneamente integrale” in cui una personale “sensibilità ecologica” intreccia “senza forzature crisi economica, sociale e ambientale”. Tutto espresso in una scrittura che pratica la lentezza per seguire il ritmo della scoperta senza mai nascondere il proprio punto di vista di “giornalista militante”, in seria connessione con quanto denuncia o annuncia. Molto spazio infatti è lasciato all’incontro e ai dialoghi con i vari interlocutori, che vengono descritti come nei servizi tv si vedono accadere. È dunque un libro che si legge come si guarderebbe un documentario, con interesse crescente che si fa preoccupazione, ma poi anche sollievo e voglia di saperne di più.
E infatti si imparano cose piuttosto interessanti in queste pagine. Innanzitutto, che diversi agricoltori locali già dagli anni ’80 hanno fatto con i semi quello che alcuni programmi europei hanno fatto con gli animali (lupi e orsi, per esempio), ovvero hanno proceduto a “ripopolare” terreni locali con semi e piante autoctoni, riportando in vita le specie quasi scomparse o dimenticate. Sono persone che si sono organizzate all’inizio da sole, ma poi hanno sparso il verbo di una nuova agricoltura fondata sulla valorizzazione della biodiversità locale come metodo di coltivazione che contrasta il cambiamento climatico sfruttando le naturali proprietà delle piante (quella di riprodurre tendenzialmente specie più resistenti o che hanno meno bisogno di irrigazione costante), o degli insetti (i famosi antagonisti come alternativa ai fitofarmaci). Non solo: la sostenibilità professata da questa impostazione si fa argine anche allo spopolamento perché fornisce ai più giovani la possibilità di restare sul territorio facendo un lavoro che possa dar loro da vivere in armonia con il territorio stesso, di cui recuperano antiche coltivazioni o contribuiscono a mantenerne di più resistenti, ma in un’ottica economica fondata sulla condivisione e sull’equità.
Si scoprono per esempio realtà nella Valle Belluna come Orti Rupestri, a San Tomaso Agordino, dove si scambiano e si conservano antiche sementi, quelle che per secoli hanno dato da vivere agli abitanti dell’agordino, e che forma “custodi dei semi” che hanno anche imparato nuove tecniche di coltivazione. Parliamo di un territorio noto un tempo per la coltivazione di orzo, mais, patate, come si evince dalle vecchie fotografie: e a cercare bene, sono venute fuori sementi avvolte in carta di giornale 50 anni fa e poi letteralmente rimaste chiuse nei cassettoni delle madie dei contadini, come l’orzo agordino, più grosso di quello normale.
Sono molte le coltivazioni che non ci si aspetterebbe dalle valli venete. C’è il lupino di montagna che viene tostato per fare il caffè, ci sono diverse varietà di fagioli come il gialèt della Valle Belluna, presidio slow food, i borlotti bala rossa, la tegolina striata, o anche la zucca santa bellunese che coltiva Enrica Balzan a Borgo Valbelluna, resistendo contro il sistema della “formula club” che impoverisce la terra con pochi tipi di sementi e scarsamente resistenti creati a tavolino, e rende schiavi della chimica tanti contadini in tutto il mondo. Poi c’è il mondo dei cereali: Johannes Keintzel, un austriaco di Vienna arrivato anni fa nel comune di Sospirolo dopo molto girovagare con la sua famiglia alla ricerca di un modo più naturale di vivere, ne è un esperto avendo attivato il progetto Triticum Dolomitico, dal nome di una coltura tipica del bellunese ma dimenticata.
Se si pensa che le mele siano più scontate, significa che non se ne immagina la varietà: Belfiore, Bella di Bosco, Regine delle Renette, Renette Ruggini, Pomi della Rosetta, Pomi dal Oio, dai mille sapori diversi, fra di loro e sicuramente rispetto al normo-sapore a cui le nostre papille si sono assuefatte comprando al supermercato le solite Golden o Fuji, mangiate magari anche 10-12 mesi dopo che sono state raccolte, e in cui sono state conservate sotto azoto. Lo stesso vale per le pere. Questa biodiversità è frutto di un lavoro di realtà come il Vecio Pomer di Oscar Padovani che con il figlio lavora in località Paderno, comune di San Gregorio nelle Alpi, ai margini del Parco delle Dolomiti Bellunesi. Lui era uno di quei ragazzi che si andava a rubare le mele sugli alberi: poi di ragazzi come lui ce ne sono stati sempre di meno e le mele hanno saputo di poco. “Salvo alberi e pianto alberi, quando posso vado in montagna” è il suo mantra.
Inaspettata è la coltivazione dei pomodori, che nell’immaginario comune vengono piuttosto associati all’intenso sole del sud e invece si coltivano anche in montagna: ne parla Tiziano Fantinel, co-fondatore di Coltivare Condividendo, associazione-guru di Porcen, frazione di Seren del Grappa, che recupera vecchie sementi e le condivide con le famiglie del territorio perché a loro volta possano crearseli da soli, propagandone la vita.
Sono solo alcuni esempi dell’inteso lavoro di Mencini, che ha viaggiato e riportato nel libro molte esperienze raccolte in Val Bormida fra le colline torinesi, nei dintorni di Roma, fra i grani antichi di Abruzzo e Molise, fino alla “contadinanza necessaria” della Calabria. Territori dove il problema è l’emigrazione, l’abbandono, l’incuria o al contrario tecniche di agricoltura intensiva, w dove invece le radici non sono solo quelle degli alberi coltivati, ma anche delle generazioni che lì vivono nei secoli e che si sono tramandate, nonostante tutto, una sapienza antica.