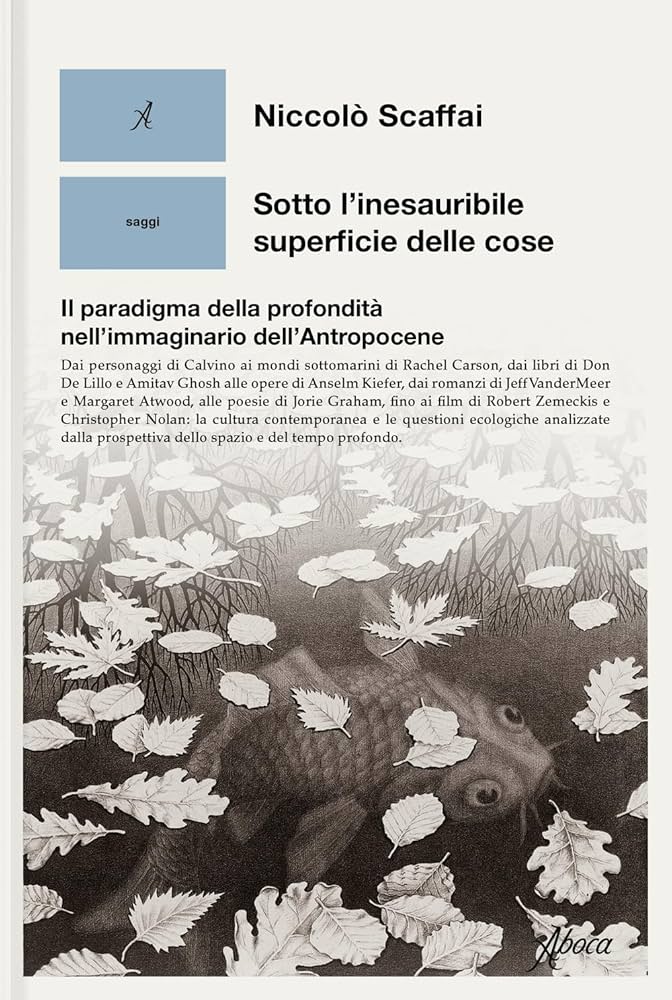Lo splendido panorama osservabile dal Monte dei Cappuccini. Foto Museo Nazionale della Montagna - Cai Torino
Lo splendido panorama osservabile dal Monte dei Cappuccini. Foto Museo Nazionale della Montagna - Cai TorinoSarà forse venuta voglia, ai lettori di Katia Tenti, di andare a visitare il museo di Castel Présule, a Fiè allo Sciliar, in Alto Adige, passati i brividi del romanzo E ti chiameranno strega (vincitore assoluto del premio Itas 2025, oltre che della sezione “Vita e storie di montagna”), ambientato proprio nell’antico castello che nel ‘500 fu teatro di brutali processi a una trentina di donne del popolo accusate di seguire il demonio, finiti in altrettante esecuzioni. E magari le recenti notizie sullo stato di avanzamento dei lavori partiti a Elva, 80 abitanti in Valle Maira, resi possibili dal super finanziamento da 20 milioni di euro del bando PNRR “Borgo dei borghi”, hanno incuriosito quei pochi che ancora non hanno letto L’inventario delle nuvole di Franco Faggiani a recarsi al Museo di Pels che ha ispirato la storia (“finta ma vera”, come è nello stile dell’autore) di un raccoglitore di capelli delle valli cuneesi, un’attività che un tempo fu vero e proprio motore economico e sociale di questa remota zona occitana.
Il binomio libro-museo insomma è possibile anche senza chiamare in causa i cataloghi, per quanto a volte così ben fatti da superare la mera esigenza estetica di possederli. Ecco un piccolo elenco ragionato per un’estate (anche) all’insegna della conoscenza.
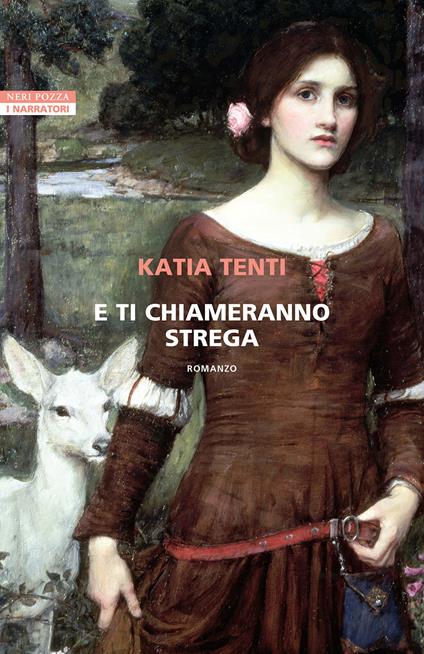 La copertina del libro.
La copertina del libro.La storia dell’alpinismo nei Messner Mountain Museum
I sei Messner Mountain Museum, dislocati fra castelli, fortezze e alture delle Dolomiti, sono fra i più suggestivi musei dedicati alla montagna. Il suo ideatore è un mito vivente e già questo spinge migliaia di visitatori a frequentarli, nonostante il biglietto d’ingresso non sia decisamente economico: vi si respira un racconto visivo e sensoriale del rapporto tra uomo e montagna, mito e fatica, spiritualità e conquista a dir poco unico. E il libro che l’alpinista altoatesino ha appena pubblicato, Breve storia dell'alpinismo in 33 oggetti (pp. 176, 19 euro, Corbaccio 2025), ne costituisce un utile catalogo ragionato con la pretesa (riuscita) di assurgere a compendio storico. Dal controverso martello di Paul Preuss, purista dell’arrampicata senza “aiutini” (a Plan de Corones), alla borsa di Edward Whymper logorata dal tempo (si sono appena celebrati i 160 anni dalla sua prima salita al Cervino, dove Marco Barmasse l’ha ritrovata nel 1985), dalla tenda di Andreas Heckmair, primo salitore della famigerata Nord dell’Eiger nel 1938, al sacco da bivacco con cui Bonatti nel 1955 affrontò da solo il Pilastro sud-ovest del Petit Dru (entrambi a Castel Firmiano), dalla corda che fu fatale a Lionel Terray nel 1965 alla piccozza lasciata, insieme alla vita, da Toni Egger sul Cerro Torre nella famigerata salita del 1959 con Cesare Maestri (a Plan de Corones). Non possono mancare oggetti di Messner stesso, come la tuta del piumino con cui ha conquistato l’Everest senza ossigeno nel ‘78 (a Castel Firmiano). Un libro perfettamente in linea con la missione di divulgazione dell’alpinismo tradizionale a cui Messner si è interamente votato, insieme alla moglie Diane Schumacher, e una bella pubblicità dei musei di cui è ideatore, in concomitanza con l’apertura della “Reinhold Messner Haus” al Monte Elmo che invece, per sopravvenute divergenze con i figli, non è diventato il settimo museo del circuito MMM da loro gestito.
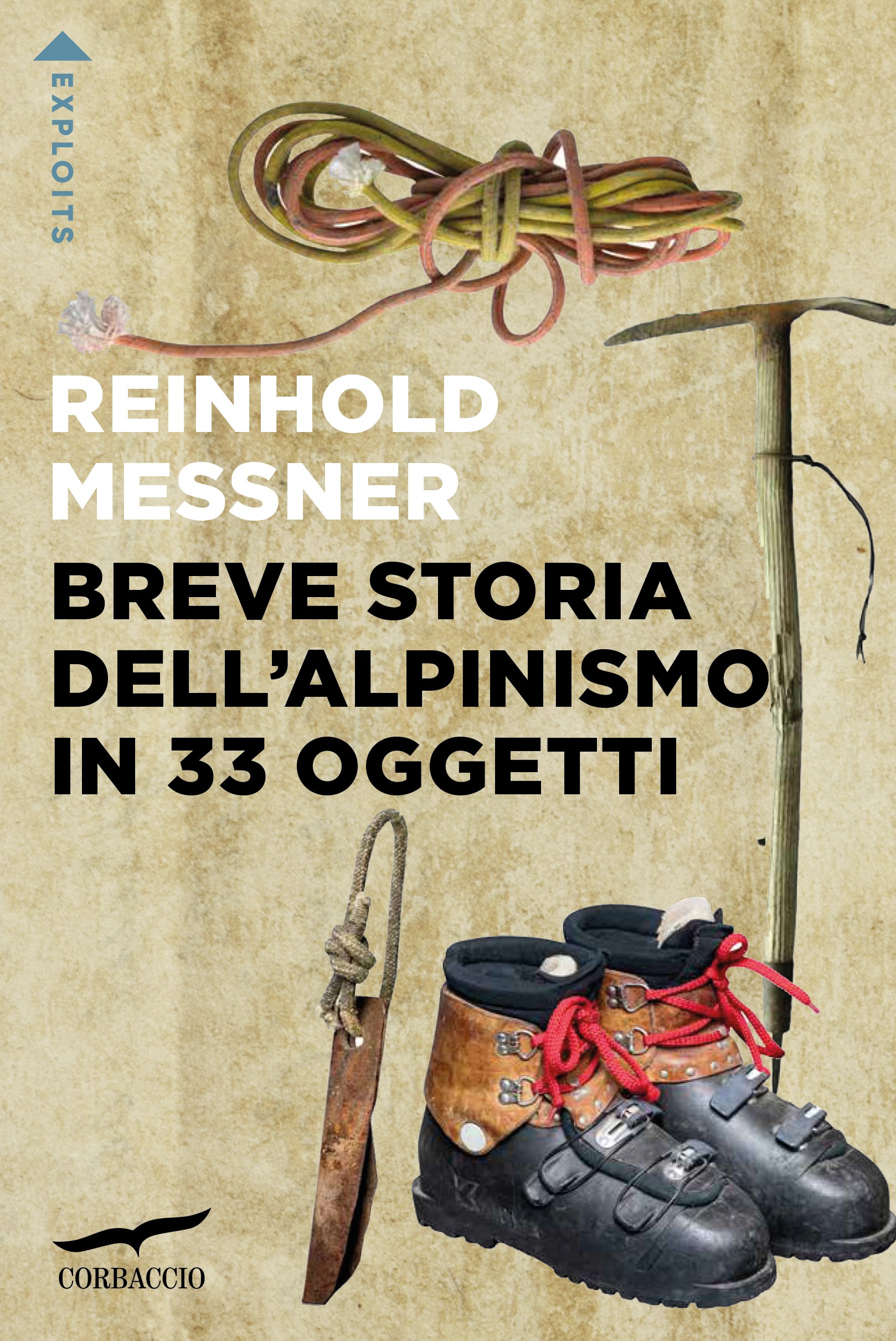
Il Museo Nazionale della Montagna di Torino custodisce l’anima visiva e documentaria dell’alpinismo italiano. È il cuore del patrimonio culturale del Club Alpino Italiano e meta obbligata per chiunque voglia respirare lo spirito che mosse i fondatori di quella che ancora oggi rappresenta la più grande associazione di montagna del Paese, la più longeva in assoluto dal dopoguerra. Intitolato al Duca degli Abruzzi, grandissimo esploratore, ospita tutto l’anno diverse mostre temporanee che ne svelano la versatilità, impreziosendone la ricca sezione permanente, fra cui spicca quella dedicata a Walter Bonatti, il cui Fondo è proprio custodito nell’Archivio del Museo. E Walter Bonatti è l’autore di un curioso volume intitolato I fumetti ritrovati, a cura di Angelo Ponta (pp. 208, ill., 24,90 euro, Solferino 2025), pubblicato in occasione dell’omonima mostra che resterà aperta fino al 15 marzo 2026. Si tratta di tavole illustrate a mano, pubblicate originariamente su riviste d’epoca e dimenticate per decenni: il Bonatti pop in chiave “Marvel” è un supereroe ironico e fantasioso, che ci fa riflettere su come anche l’epica possa concedersi il lusso della leggerezza. Prima di andare via, se le condizioni lo consentono, che sia giorno o che sia notte, vale la pena perdersi ad ammirare l’orizzonte della terrazza panoramica. In fondo svettano le Alpi con l’impertinente Monviso da cui tutto partì nel 1863.
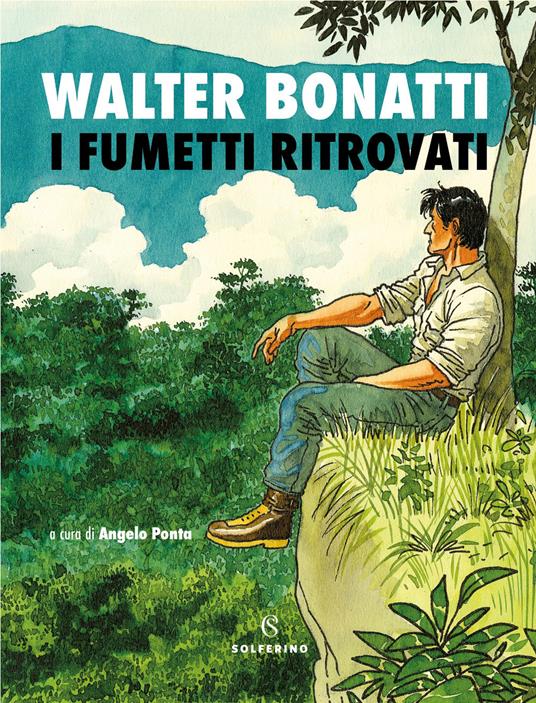
Il futuro fra pagine e stanze
Chi invece avrà occasione di andare oltreoceano può inserire nella nutrita “watchlist” degli Stati Uniti il Climate Museum di New York. Fondato nel 2015, è la prima istituzione statunitense interamente dedicata al cambiamento climatico, con l’obiettivo di trasformare preoccupazione passiva in impegno attivo. Nato come progetto itinerante dopo l’uragano Sandy, si trasferirà nella nuova sede permanente che sarà pronta nel 2029. Fra le sue attività ci sono mostre temporanee, sezioni tematiche (fra cui una sulla perdita dei ghiacciai “in deep time”) e laboratori rivolti soprattutto alla sensibilizzazione dei più giovani. Il museo è collegato a una rete che comprende analoghe realtà, di fatto l’evoluzione in salsa “antropocenica” dei cari e vecchi musei di scienze e storia naturale (che proseguono la loro azione educativa con lo sguardo sempre rivolto all’attualità): il Jockey Club Museum of Climate Change di Hong Kong, e lo spettacolare Museu do amanhã (museo del domani) di Rio, in Brasile, che l’architetto spagnolo Santiago Calatrava ha costruito ispirandosi alle bromeliacee che esplodono di colore il Giardino Botanico della città. In Europa, troviamo il Norwegian Glacier Museum di Fjærland, focalizzato sul ghiacciaio Jostedalsbreen, e l’Ice Age Centre (Estonia), dedicato alle ere glaciali in generale; la Klimahaus Bremerhaven 8° Ost (sulla costa tedesca del Mare del Nord), il Museum of Water itinerante (Gran Bretagna), Gaia Centre di Atene (Grecia).
Fa al caso allora la lettura del nuovo libro di Daniele Scaffai Sotto l’inesauribile superficie delle cose (pp. 180, 24 euro, Aboca 2025): l’antropocene non arriverà forse allo status di denominazione geologica, ma come categoria culturale si è ormai affermato. Attraverso sei lezioni (in omaggio a quelle americane di Calvino, protagonista della prima), dove prende in esame autori come Rachel Carson, Margaret Atwood e Amitav Ghosh, registi come Nolan e Zemeckis e artisti come Anselm Kiefer, Scaffai intende delineare un vero e proprio “paradigma della profondità”, perché questa categoria possa guidarci nella comprensione di noi stessi nel presente. Già Robert MacFarlane aveva adottato questo sguardo nel saggio Underland. Un viaggio nel tempo profondo (a proposito, a settembre sempre per Einaudi uscirà l’ultimo, È vivo un fiume?), perché nel mutato rapporto dell’uomo con il “sopra” e il “sotto” del Pianeta si annida una delle chiavi di lettura della nostra evoluzione culturale. Non si va più “sotto” solo per uscirne “vincitori” (per estrarre petrolio o, metaforicamente, per uscire da una situazione di rischio), ma per capire le proprie origini e riconnettersi al cuore pulsante del pianeta Terra che viviamo “sopra”, superando così la prospettiva antropocentrica.