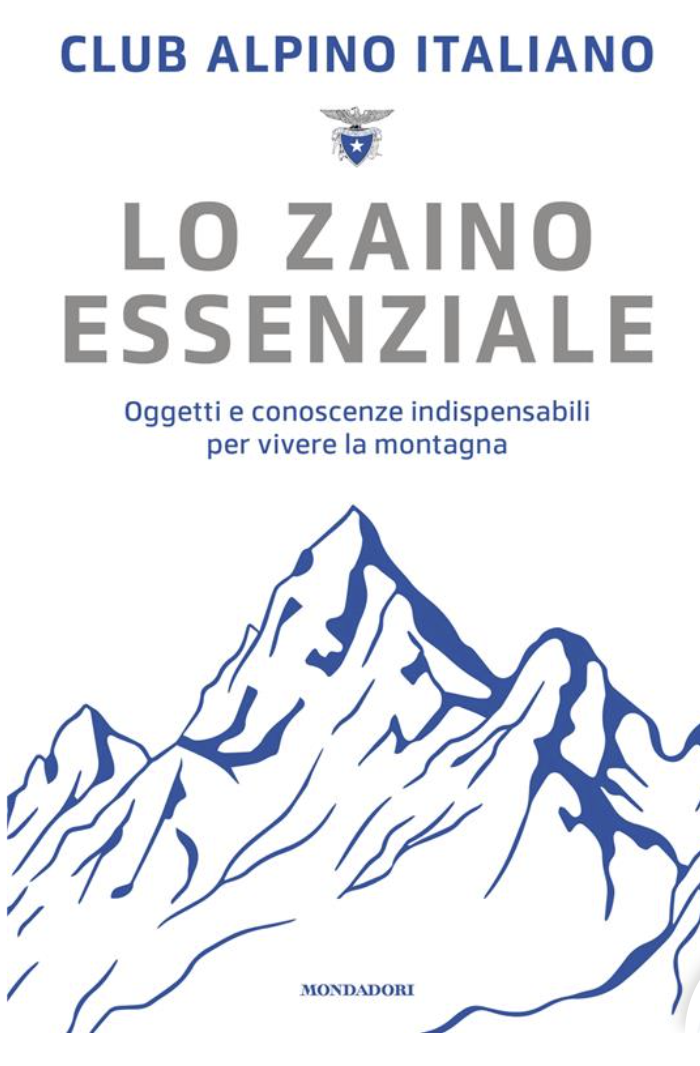 Lo zaino essenziale. Copertina del libro
Lo zaino essenziale. Copertina del libro Foto Noemi Comotti.
Foto Noemi Comotti.È la sera prima: tiriamo fuori il fidato zaino, quello un po’ rotto, un po’ bucato, ma ancora solido, dove ogni segno di usura è come una ruga di espressione, a dire che lui c’era ogni volta che siamo partiti, è invecchiato macinando chilometri con noi. E, sgombrando la mente da tutto quello che ci appesantisce l’animo, pronti a mettere la fatica solo nelle gambe, iniziamo a passare diligentemente in rassegna ciò che serve.
Prima di tutto e per qualunque tipo di uscita: giacca a vento e vestiti per il freddo, perché il tempo può cambiare e precipitarci a temperature invernali anche d’estate. Poi sempre, occhiali e protezioni per il sole, spiegarlo è quasi ovvio: il sole brucia anche dietro le nuvole, il riverbero della neve è micidiale tutto l’anno. Mappa e GPS perché vai a fidarti della rete, in montagna si sa che non sempre il cellulare prende. Poi, un kit di primo soccorso, perché non succede niente, ma se succede… meglio tenerci pronti. Anzi, il kit lasciamolo sempre nello zaino, come pure la lampada frontale: pesano poco, e possono fare la differenza. Ovviamente, cibo, borraccia e qualche sacchetto per i rifiuti: tutto quello che sale con noi scende con noi, è una regola aurea che seguiamo da anni. Se restiamo fuori, sacco letto e sacco a pelo: arrotoliamo tutto e prepariamoci al tetris. In caso di uscite alpinistiche non possono mancare corda e imbrago, ramponi e piccozza. Bene: con il livello “necessità” siamo a posto. Ma andiamo in montagna anche per godercela, anzi, per continuare a godercela anche quando siamo tornati: quindi prendiamo subito la macchina fotografica e un binocolo. E un bel libro, perché il gusto di sdraiarsi su un prato a leggere all’ombra delle vette non ha eguali. Senza scordare la tessera del socio CAI.
15 oggetti
Uno zaino così preparato dimostra esperienza e attenzione, sarà un ottimale compagno di avventura. Eppure, c’è un altro zaino da riempire, stavolta con la testa e il cuore: andare in montagna non è solo raggiungere un obiettivo, una vetta, un rifugio, è – o meglio – dovrebbe essere un atto di consapevolezza, che deriva dalla conoscenza, che è mossa dalla curiosità. Sono le tre C di cui parla Andrea Greci nella prefazione e costituiscono lo scopo profondo del Club Alpino Italiano, autore del volume Lo zaino essenziale. Oggetti e conoscenze indispensabili per vivere la montagna (pp. 312, 20 euro, Mondadori 2025, con le illustrazioni di Sara Filippi Plotegher).
Troviamo qui 15 oggetti, quelli esposti sopra, che si fanno pretesto per affrontare temi di ampio respiro che tutti insieme offrono uno sguardo sulla montagna a 360 gradi. Non si trovano qui (se non ogni tanto fra le righe) consigli pratici per l’acquisto di quella tale marca o tipologia di oggetto, o per preparare un’escursione, bensì riflessioni antropologiche e filosofiche, dati e analisi di taglio geografico, cenni storici su ogni area tematica riguardante l’ambiente alpino in sé (acqua, ghiacciai, roccia, flora e fauna) e la sua frequentazione da parte dell’uomo, con tutte le forme che questa può prendere: alpinismo, letteratura, studio scientifico.
Ogni capitolo affronta dunque un argomento collegato all’oggetto che tratta, di cui presenta un vademecum di 7 “cose da sapere” e un glossario da 10 parole, grazie alla penna di contributori esperti con cui il Club Alpino già collabora attivamente in diverse modalità.
La borraccia è lo spunto per l’idrogeologo Matteo Nigro (coordinatore scientifico del progetto Acquasorgente) per parlare di acqua, con tutto ciò che significa in tempo di cambiamento climatico, che vede i rifugi affrontare sempre più il tema della siccità. Il kit di primo soccorso serve al giornalista Simone Bobbio per approfondire il concetto di “cultura della prevenzione” e la storia del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, di cui cura la comunicazione. La macchina fotografica e il binocolo ci introducono, grazie a Denis Perilli e Anna Sustersic, fra le altre cose autori per le guide ufficiali del Sentiero Italia CAI, al mondo della flora e della fauna alpine, ricordandoci che le piante comunicano fra loro e riflettendo sul perché il selvatico ci attiri e allo stesso tempo ci impaurisca così tanto, in quella speciale dialettica che è la coesistenza fra uomini e animali. Parlando di abbigliamento e di protezione solare Marta Corrà ci introduce alla meteorologia alpina e alla glaciologia, per farci capire per esempio qual è l’impatto di un meteo impazzito sull’alpinismo, lei che è alpinista e studiosa proprio di queste materie. Quell’alpinismo di cui Enrico Camanni racconta una breve storia disquisendo di corde e imbrago, per poi allargare lo sguardo al senso della sua evoluzione fino a oggi. Cibo per parlare con il geografo Mauro Varotto del divario crescente fra un sempre più sfrenato marketing della montagna e le realtà produttive locali, e riflettere sui cosiddetti prodotti tipici. Sacchetti per i rifiuti per ripassare, con Irene Borgna, le buone pratiche che rendono il nostro passaggio in montagna più sostenibile in base alle diverse situazioni in cui ci si trova. Sacco a pelo e sacco lenzuolo come emblemi del bivacco di cui Luca Gibello racconta i 100 anni dalla prima invenzione, da parte del Club Alpino Accademico, così come la lampada frontale ci racconta la meraviglia di albe e tramonti in quota, e cosa succede sui monti quando imperversa la notte (Borgna), e così come un libro dice tutto del nostro sguardo sul verticale, del nostro bisogno di raccontarlo e di come sia cambiato nei secoli (Camanni).
Un autore plurale
Sono temi che il Club Alpino approfondisce con progettualità complesse e articolate su più anni: come Acquasorgente, il progetto di citizen science per mappare tutte le sorgenti d’acqua italiane, come il Portale Rifugi, tramite cui è possibile prenotare un posto letto nelle migliori strutture lungo i percorsi escursionistici italiani, come CAI Eagle Team, il progetto di formazione che seleziona giovani talenti dell'alpinismo, per non parlare dei diversi accordi di collaborazione con enti e parchi su scala nazionale per la protezione dell’ambiente, argomento affrontato anche attraverso la pubblicazione di libri con il marchio CAI Edizioni e con il sostegno a importanti produzioni cinematografiche proposte a tutti i soci con sconti per l’accesso in sala.
Per questo l’ultimo capitolo è dedicato alla tessera CAI, punto di partenza per ricordare cos’è e cosa fa il Club Alpino Italiano, un’associazione da oltre 350mila soci e più di 500 sezioni in tutta Italia, nata nel 1863 a Torino con lo scopo di promuovere la frequentazione, lo studio e la conoscenza della montagna, in tutte le sue forme, anche attraverso la manutenzione dei sentieri, la costruzione di rifugi alpini (sono più di 18mila i posti letto disponibili nelle proprie strutture), la vigilanza e la prevenzione degli incidenti, o il loro soccorso (grazie al Soccorso Alpino), e infine la formazione e la didattica.
E per questo il CAI risulta come autore: perché dietro a ogni pagina, c’è una conoscenza maturata nel tempo da tutti coloro che si sono passati il testimone nel compito, non sempre facile, di diffondere la passione per la montagna.
Ci sono due categorie di lettori. Quelli che leggono questo libro perché curiosi di approfondire temi con cui hanno già familiarità e quelli che lo leggono perché vogliono avvicinarsi da una prospettiva insolita al mondo della montagna. (Irene Borgna)