 Vacche in alpeggio
Vacche in alpeggio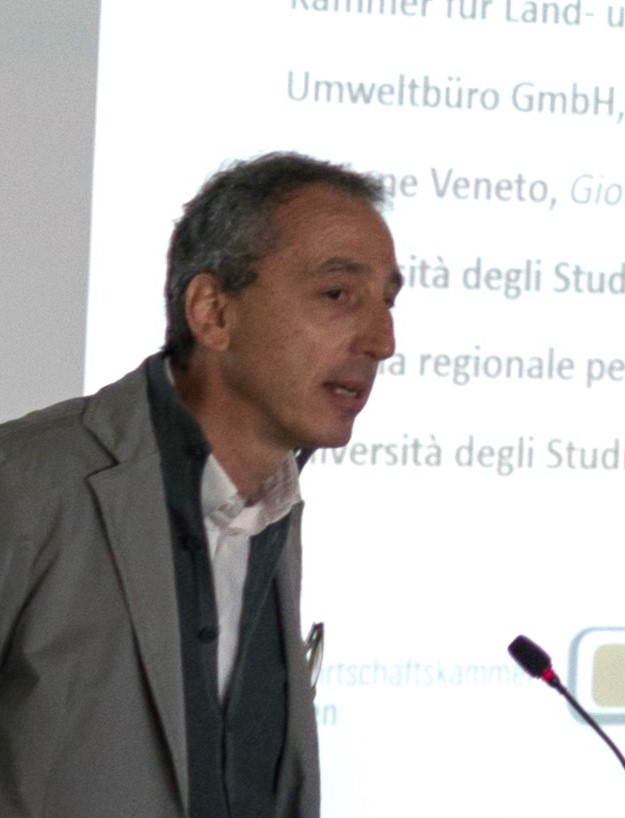 Il professor Bovolenta
Il professor Bovolenta Pecore in alpeggio
Pecore in alpeggio La locandina del convegno
La locandina del convegnoIn un contesto in cui la convivenza tra pascoli e grandi carnivori – orsi, lupi e linci – solleva dibattiti complessi e talvolta polarizzati, il Convegno nazionale del CAI in programma a Gubbio il prossimo 20 settembre, assume un ruolo centrale. Con competenza, apertura e pragmatismo, mira a costruire un ponte di dialogo tra mondi che spesso sembrano contrapporsi: quello agricolo e zootecnico della montagna, e quello della conservazione faunistica. L’appuntamento diventa così un’opportunità preziosa per approfondire una sfida che non si affronta più solo con soluzioni tecniche, ma con ascolto reciproco e visione integrata. Iscriversi è facile, è sufficiente compilare un form.
Moderatore del convegno sarà Stefano Bovolenta, professore ordinario di Zootecnia Speciale all’Università degli Studi di Udine. Da molti anni si occupa di sistemi di allevamento estensivi in ambiente montano, con particolare attenzione al benessere degli animali al pascolo, alla biodiversità, alla sostenibilità ambientale e agli effetti delle scelte gestionali sulla qualità dei prodotti. È socio fondatore, ed è stato presidente, della Società per lo Studio e la Valorizzazione dei Sistemi Zootecnici Alpini (SoZooAlp), realtà che da oltre venti anni affronta le sfide della zootecnia montana, compresa quella derivante dalla crescente presenza della fauna selvatica.
Abbiamo raccolto la sua testimonianza in questa intervista, che introduce e approfondisce i temi al centro del Convegno nazionale del CAI “Non basta proteggere, serve comprendere”, convegno inserito anche nel programma di festeggiamenti per il centenario francescano e al quale partecipetà anche il componente del comitato direttivo centrale Mario Vaccarella che ha la delega su questi temi.
Professor Bovolenta, lei è stato invitato a moderare il Convegno nazionale CAI sul delicato tema della coesistenza tra attività agro-zootecniche e grandi carnivori in montagna. Qual è la situazione attuale?
Innanzitutto ringrazio il CAI, e in particolare Davide Berton, per il gradito invito.
Il tema della coesistenza tra forme di allevamento estensive - pensiamo ad esempio alla transumanza bovina piuttosto che alle greggi erranti - e fauna selvatica ha assunto una crescente rilevanza negli ultimi decenni, in particolare in ambiente montano.
A partire dal secondo dopoguerra, infatti, il progressivo spopolamento della montagna e la conseguente contrazione delle attività agro-zootecniche tradizionali ha comportato la ricolonizzazione di specie selvatiche, inclusi i grandi carnivori, che nel recente passato erano state controllate, spesso in modo drastico, con lo strumento venatorio.
Questo fenomeno determina inevitabili sovrapposizioni tra fauna selvatica, la cui presenza è di estrema importanza sul piano ecologico, e attività zootecniche ancora presenti, fondamentali non solo per le produzioni agricole e il presidio/controllo sostenibile del territorio, ma anche per la loro capacità di erogare importanti servizi ecosistemici e garantire la biodiversità a diversi livelli.
Tuttavia, questa coesistenza genera tensioni e conflitti, spesso aspri, e le categorie più colpite, come gli abitanti e gli allevatori della montagna, spesso lamentano un’assenza di adeguate politiche di gestione. Politiche di gestione della fauna che sono innegabilmente influenzate da un'opinione pubblica molto sensibile ai temi della conservazione e dei diritti degli animali e spesso incline a considerare le attività agricole e zootecniche impattanti sul piano ambientale e poco attente al benessere e alla salute animale.
In questo contesto qual è la possibile rilevanza del Convegno?
È mia opinione che questo Convegno promosso dal CAI, visto l’approccio multi-disciplinare e il livello dei relatori, sia di grande rilevanza poiché fornirà informazioni e chiavi di lettura utili per comprendere l’importanza e la cogente necessità di trovare un equilibrio, o meglio un compromesso, tra presenza di grandi predatori e attività zootecniche ovvero tra sforzi conservativi e necessità produttive e di presidio del territorio.
Entriamo negli argomenti del convegno. In che modo la presenza di orsi, lupi e linci ha modificato la vita quotidiana degli allevatori di montagna?
La presenza della fauna, causa di danni e competizione trofica oltre che di predazioni, non è l’unico problema degli allevatori di montagna, che affrontano vecchie e nuove sfide, anche economiche e sociali. Senza la pretesa di essere esaustivi, si pensi ai costi di produzione, all’isolamento e alla mancanza di servizi, agli effetti del cambiamento climatico, al problema del ricambio generazionale e della scarsa disponibilità di personale qualificato. È pur vero che, a fronte di queste difficoltà e dei servizi erogati – tra gli altri, il mantenimento della biodiversità e del paesaggio, la conservazione di razze autoctone, il controllo dell’erosione e degli incendi - gli enti pubblici, utilizzando le risorse messe a disposizione nell'ambito della PAC, riconoscono e remunerano i servizi e prevedono sostegni e indennità, pur con problemi e lentezze burocratiche.
Questa premessa per dire, o meglio ribadire, che l’allevatore di montagna oggi deve potersi riconoscere in una figura di imprenditore agro-ambientale, capace di muoversi sia sul mercato dei prodotti sia su quello dei servizi e di tramutare i diversi problemi e vincoli ambientali e sociali in vantaggi competitivi. Formazione degli operatori, ricambio generazionale e informazione al cittadino consumatore-contribuente sono fondamentali per accompagnare questo necessario passaggio.
Quindi?
Per rispondere alla domanda, la presenza dei grandi carnivori negli ultimi anni ha modificato, spesso profondamente, la vita quotidiana degli allevatori di montagna. Al di là dell’aggravio di lavoro e delle perdite economiche dirette e indirette, gli allevatori devono affrontare un significativo stress psicologico ed emotivo, spesso accompagnato da un senso di impotenza. Impotenza legata alla percezione della prevalenza degli interessi che potremmo definire “urbani” rispetto a quelli legati alla realtà montana. Più chiaramente potrei dire che i decisori politici sembrano più sensibili, o sono vincolati in qualche modo, alle istanze e alle sensibilità dei fruitori della montagna piuttosto che di chi la vive e la conosce.
In sintesi sono ragionevolmente certo che anche la gestione della fauna nei diversi contesti montani possa diventare parte di quei servizi erogabili dall’azienda agro-zootecnica multifunzionale di montagna. L’imprenditore agro-ambientale sarà sempre un alleato di chi vorrà gestire la montagna superando approcci meramente conservativi.
Quali sono oggi gli strumenti più efficaci per prevenire i danni agli allevamenti visti dalla prospettiva dell’allevatore?
A parte gli strumenti normativi e le buone pratiche gestionali, che dovrebbero essere messe in atto a monte per mantenere le popolazioni selvatiche in uno status di conservazione soddisfacente, ma compatibile con la presenza sul territorio di attività allevatoriali, alcune misure di prevenzione, in parte tradizionali e altre innovative, sono risultate utili per ridurre il rischio di predazioni.
Le recinzioni elettrificate, sia fisse che mobili, sono una soluzione molto valida ed economicamente conveniente, in grado di impedire l'accesso ai predatori oltre a contenere il bestiame. Queste possono essere abbinate a dissuasori acustici e visivi.
I cani da guardiania sono considerati molto efficaci, specialmente se adeguatamente addestrati e integrati nel gregge. Si deve tuttavia tenere conto che, in contesti molto turistici, possono creare situazioni potenzialmente pericolose per gli escursionisti, in particolare quelli poco informati sui comportamenti da tenere e sui rischi connessi.
Ci sono tecnologie o approcci innovativi emersi e sperimentati dal mondo zootecnico negli ultimi anni?
Negli ultimi anni, il mondo zootecnico e la ricerca hanno sperimentato anche approcci innovativi. Senza entrare nei dettagli, che certamente verranno proposti al Convegno, possiamo annoverare tra questi il monitoraggio con tecnologie GPS del bestiame allevato, abbinato a termocamere, fototrappole e sensori di passaggio perimetrali al pascolo. È sempre più utilizzato il telerilevamento satellitare abbinato al drone per il monitoraggio della fauna selvatica e la stima dei danni agricoli. Recentemente si stanno studiando repellenti di varia natura; ad esempio, alcuni ricercatori svizzeri stanno testando l'efficacia di collari anti-lupo. Il metodo prevede che il collare sia dotato di feromoni di lupo mescolati a cera vegetale che dovrebbero "ingannare" il predatore inducendolo a pensare che il territorio sia già stato occupato da altri individui conspecifici.
Tuttavia, fermo restando la necessità della ricerca e della sperimentazione, è importante considerare che non sempre le soluzioni, sia tradizionali sia innovative, sono proponibili e realizzabili in tutti i contesti, ad esempio a causa di costi elevati, vincoli orografici o sociali, eccessivo carico lavorativo.
Avete riscontrato differenze tra percezione del rischio e dati reali sui danni da predazione?
Si, indagini svolte in diversi contesti territoriali hanno messo in evidenza che la percezione del rischio tende ad essere superiore rispetto al reale impatto che questi animali possono avere sul comparto agro-zootecnico. Sebbene statisticamente il numero di capi predati sia spesso una percentuale esigua rispetto al patrimonio zootecnico complessivo, le singole predazioni o le serie ripetute di attacchi su una stessa azienda generano, come già accennato, un forte carico emotivo e vivaci contestazioni.
È comunque importante tenere in considerazione che, talvolta, i danni non vengono dichiarati e denunciati a causa delle difficoltà burocratiche per ottenere gli indennizzi previsti. Inoltre, i danni indiretti, quali per esempio perdita di produzione, stress, aborti, valore genetico del capo predato, ecc. non vengono presi in considerazione. Questo crea ulteriore malcontento tra gli allevatori, che ritengono non adeguato il sistema e le modalità di indennizzo.
È così anche dove i predatori sono sempre stati presenti?
Anche in aree di lunga coesistenza con lupi e orsi, è il caso ad esempio del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, la tolleranza degli allevatori può rimanere bassa, pur nella generale consapevolezza del valore ecologico dei predatori. Tuttavia, in queste situazioni, gli allevatori hanno sviluppato un’esperienza e una serie di misure difensive evidentemente efficaci, che portano ad un minore impatto delle predazioni rispetto ad altre aree montane. È il caso del contesto alpino, dove per lungo tempo il fenomeno delle predazioni è stato assente o marginale, e dove attualmente sia la popolazione residente sia, in particolare, gli allevatori incontrano difficoltà nell’adottare misure adeguate di prevenzione e gestione del problema.
Cosa serve per immaginare davvero un futuro in cui pastorizia e grandi carnivori coesistano in qualche modo?
Per immaginare un futuro di coesistenza sarebbe importante riconoscere le attività agro-zootecniche estensive come parte integrante degli ecosistemi montani, valorizzandone la multifunzionalità e il ruolo per la biodiversità e il paesaggio, anziché vederle come un problema, o il problema, che limita i progetti di conservazione. Come anticipavo è anche necessario che l’allevatore diventi un imprenditore agro-ambientale, con risvolti positivi anche per la sua considerazione sociale, e che i concetti di “tutela” e “conservazione” siano affiancati al concetto di “gestione sostenibile”.
Inoltre, senza che quanto dico suoni come una banalità, serve una sinergia continua tra istituzioni, ricerca e comunità locali, in grado di generare comprensione reciproca piuttosto che contrapposizione. Formazione, informazione e coinvolgimento degli allevatori o, meglio, imprenditori agro-ambientali, nei processi decisionali sono ulteriori passi fondamentali. Solo così si potrà pensare di realizzare efficaci e condivise strategie di conservazione e gestione della fauna.
Che tipo di supporto dovrebbe arrivare dalle istituzioni pubbliche per accompagnare questa transizione?
Le istituzioni pubbliche dovrebbero fornire un supporto concreto e coerente. Questo include misure di difesa e prevenzione, indennizzi rapidi ed equi, formazione e assistenza tecnica sia per gli allevatori sia per i tecnici coinvolti, supporto alla ricerca e alla sperimentazione.
Per concludere, da ricercatore devo mettere in evidenza il problema della qualità dei dati disponibili. Questi sono raccolti dalle istituzioni pubbliche con finalità prevalentemente amministrative e, di conseguenza, sono spesso carenti sul piano del loro possibile utilizzo per la ricerca.