 Marco Mensa promo.jpg) Davide Sapienza. Foto Marco Mensa.
Davide Sapienza. Foto Marco Mensa. Lettura del libro in anteprima durante i "Sentieri selvatici", settembre 2025. Foto Davide Sapienza.
Lettura del libro in anteprima durante i "Sentieri selvatici", settembre 2025. Foto Davide Sapienza. Un momento dei "Sentieri selvatici" 2025. Foto Davide Sapienza.
Un momento dei "Sentieri selvatici" 2025. Foto Davide Sapienza.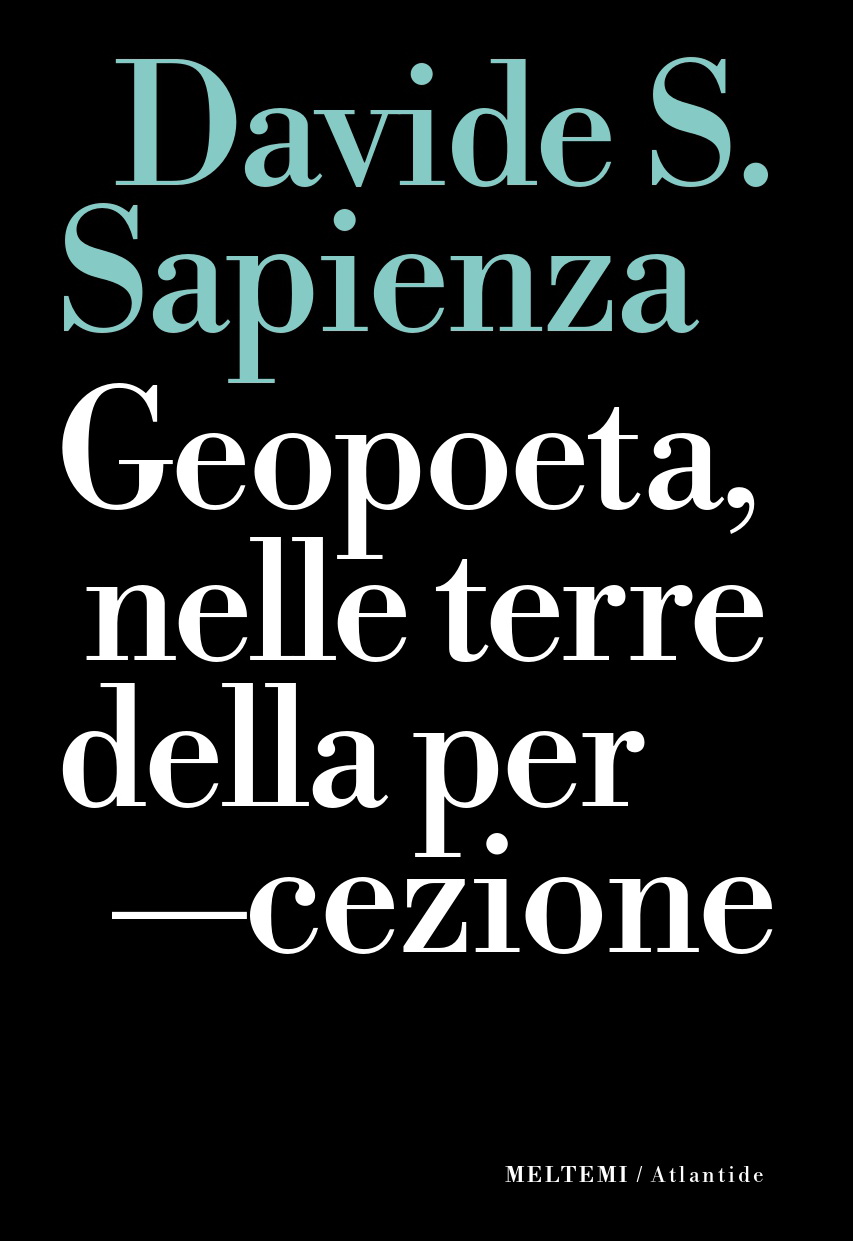 La copertina del libro.
La copertina del libro. Davide Sapienza con il nuovo libro, là dove è stato ispirato. Foto Davide Sapienza.
Davide Sapienza con il nuovo libro, là dove è stato ispirato. Foto Davide Sapienza.Scrittore, giornalista, traduttore, critico musicale, poeta, organizzatore di eventi, fotografo, podcaster: Davide Sapienza non ama le etichette e lo dimostra con l’eclettismo che lo contraddistingue da sempre. Dopo Nelle tracce del lupo, pubblicato nel 2024 con Lorenzo Pavolini, torna in libreria con il libro che forse lo rappresenta di più: Geopoeta, nelle terre della percezione (pp. 176, 16 euro, Meltemi 2025), che diventerà presto anche un podcast curato dall’editore.
È un diario di esperienze, un racconto filosofico e culturale dalla scrittura travolgente come l’onda d’urto di una valanga e ipnotica come un mantra. Una lettura che non lascia indifferenti, per quanto complessa, e fa leva sulla parte più emotiva di ogni frequentatore che abbia a cuore la montagna non solo come terra di prestazione fisica, ma anche come luogo fragile soggetto a un cambiamento inesorabile ed epocale.
Nel volume, che si presenta completamente rinnovato nei contenuti, compaiono le illustrazioni di Vittorio Peretto, paesaggista e fondatore di Hortensia, il team a cui è stata affidata la gestione dell’Oasi Zegna a Milano, e un qr-code per visionare l’opera del regista Marco Mensa, che esprime per immagini l’essenza geopoetica, quella sensibilità che tutti abbiamo di metterci in connessione con l’elemento naturale e che oggi sembra andare tanto di moda.
Non per Davide Sapienza, che questi temi li affronta da anni, grazie alla scoperta di autori come Barry Lopez (1945-2020), uno dei più grandi narratori americani di natura e paesaggi di cui era diventato amico, e l’avvicinamento alla filosofia delle culture native, che in montagna ci è andato a vivere molto tempo fa e oggi, passata la boa dei 60, si definisce “un selvatico che se ne sta per i fatti suoi”. Anche se non disdegna di far provare quella “selvaticità” anche ad altri, dimostrando che in fondo siamo tutti geopoeti come lui, perché il selvatico dimora in chiunque abbia voglia di riscoprirlo. Così succede a quanti per esempio partecipano ai cammini estivi che da anni organizza in montagna e che finiscono ormai sold out in pochi giorni: si intitola proprio “Nei sentieri selvatici” la seconda edizione della rassegna realizzata quest’anno insieme al Parco Regionale dell’Adamello, che termina il 21 settembre (data non casuale, è il periodo dell’equinozio d’autunno).
Davide Sapienza, che cos’è un geopoeta?
Il geopoeta non esiste: o non ce n’è neanche uno, o lo siamo tutti, anche chi non lo sa. Geopoeta è chi riesce a estrarre dal paesaggio essenze diverse – bellezza, luce, benessere – contro una visione utilitarista che divide la natura in utile e inutile. Sono consapevole che la nostra società ha bisogno di codificare sempre tutto, ma io non mi sono mai voluto impegnare davvero a rispondere a questa domanda, perché non voglio pormi come “il geopoeta”, e infatti per questo il titolo è cambiato in questa nuova edizione: esiste una “pratica geopoetica”, ma non intendo imporre la mia ad altri, ciascuno trova la sua. Io non sono uno specialista, non sono un antropologo, sono il canale attraverso cui scorre una sensibilità che già c’è. Non ho un rituale predefinito di gesti, letture, perfino gli itinerari restano aperti. Settimana scorsa siamo arrivati vicino alla Val Miller, in Adamello, non era in programma, ma era troppo bella, ho radunato la squadra come un allenatore e insieme alla nostra guida ci siamo diretti lì attraverso un sentiero spettacolare. Una cosa che mi resterà dentro per sempre.
Allora diciamo che tu aiuti a tirare fuori il geopoeta che c’è in ciascuno di noi, è per questo che i “Sentieri geopoetici” vanno sempre sold out?
Provo gratitudine verso la terra che ci accoglie e verso quanti si mettono in gioco (e sono soprattutto le donne a farlo), percorrono anche tre ore di auto per arrivare, poi ne passano dieci in montagna con me (non tutte a camminare, ma arriviamo a volte a fare anche una quindicina di chilometri e quasi mille metri di dislivello), ascoltano le mie letture, “percepiscono” insieme a me e io con loro e poi sanno tirare fuori una frase che mi lascia a bocca aperta. Quasi sempre poi chiedo a ciascuno di pensare a una parola e di dirmela uno alla volta: sono sempre diverse, perché ogni persona ha una sua percezione del paesaggio. È un’esperienza pratica che mi arricchisce moltissimo e di cui non riesco a fare a meno. Ho capito con largo anticipo il bisogno di cambiamento delle persone: Jack London scriveva che l’uomo è la creatura più irrequieta del Pianeta.
Ti aiutano anche a scrivere i tuoi libri?
Ho letto a queste persone alcuni capitoli di Geopoeta in anteprima ed ero disposto a non pubblicarli se non fossero piaciuti. Nel capitolo “Montagne orizzontali” racconto l’episodio di una signora, di cui non ricordo il nome purtroppo, che mi fece notare quanto la parola “sentieri” fosse simile a “sentire”, un’assonanza potente a cui non avevo mai pensato. Confesso che prima di rimettere mano a questo libro ero un po’ in crisi con la scrittura, dopo tanti lavori, con l’Unesco, con i parchi nazionali dell’Artico, spesso all’estero. Con la pratica geopoetica, andando in montagna, ascoltando le persone, mi è tornata la voglia. È come se ogni volta andassi in tour, come un gruppo musicale: mi piace testare dal vivo le mie cose.
“Geografia è poetica e la poesia è una geografia dell’umano sentire” scrivi. Come fai a trovare poesia nella geografia?
Geografia per me è sinonimo di avventura, e l’avventura è confronto con te stesso, rispecchiamento nei confronti della geografia che ti circonda, che ci siano o meno segni umani. A me, che vivo con la Presolana sempre a portata di sguardo, basta andare in Val Camonica per trovare il mio giardino artico, dove “artico” è metafora per qualcosa di lontano, profondo, trasparente, un’espansione di coscienza. In Lombardia potremmo fare un cammino a settimana e sceglierne sempre uno diverso, ci sono 15mila km di sentieri al 70% gestiti dal CAI. E anche se rifacessimo lo stesso, saremmo diversi noi, quindi sembrerebbe nuovo. Questa per me è la geografia.
Forse la materia peggio insegnata e ancor peggio studiata a scuola, salvo eccezioni ovviamente. Hanno provocato molte polemiche le nuove linee guida del Ministro Valditara di non insegnarla più come materia a sé, ma di accorparla alla storia.
Non concordo per niente con l’idea di togliere lo studio della geografia, che a scuola è sempre stata insegnata come pura teoria: quali sono gli affluenti del Po, dove si trova questa o quella città… È importante saperlo, ma geografia non è solo teoria, è soprattutto pratica. Gli intellettuali avrebbero bisogno di alzarsi dai loro divani, perché il mondo non è solo quello che vivono nella loro testa. Me lo insegnano da trentacinque anni le persone che incontro ogni giorno qui in montagna, dove vivo.
Cos’è il “lessico dei sentieri”?
È un’idea che mi è venuta durante la pandemia, doveva diventare un libro, poi non se ne è fatto nulla (è però diventato un articolo per l’Annuario del CAI Bergamo nel 2020, NdA). L’ho scelto come titolo dell’edizione 2022 della rassegna di cammini che organizzavo con l’officina culturale Alpes di Milano per il Sistema Bibliotecario della Val Seriana, “Nel cuore della montagna”. I sentieri hanno un loro linguaggio, un loro modo di parlarci, di indirizzarci, ma soprattutto un loro modo di dirci perché sono nati. Si vede infatti se un sentiero nasce per essere percorso dal bestiame o dall’esercito, da come si insinua nella montagna, da come è disegnato. Io invito le persone a farci caso, a rifletterci mentre ci camminano sopra.
Parlavi di “montagna orizzontale”, cosa intendi?
La montagna è verticale o addirittura verticistica per antonomasia. Rifiuto questa visione che risponde troppo a un modello vecchio, ormai superato. La cima, il dislivello, i metri, la performance contano di meno oggi: la montagna orizzontale è un orizzonte, l’orizzonte di libertà che ci diamo quando andiamo a camminare.
Sei per metà di Monza, per metà siciliano dell’Etna, ma da trentacinque anni vivi in un piccolo paese di montagna, uno di quelli che d’estate si farcisce di turisti. Come affronti l’overtourism?
Ormai ho passato più di metà della mia vita in montagna dove in realtà venivo fin da quando avevo 6 anni per almeno due mesi all’anno. L’overtourism è una grande scocciatura, significa metterci 15 minuti di macchina quando di solito ne servono 3, o prenotare almeno 5 giorni prima il ristorante del tuo amico dove ti infili normalmente senza preavviso. Il vero problema è la pressione che si crea su un ambiente così particolare come la montagna, che viene trasformata in una sorta di parco divertimenti. Detto questo ho una visione aperta: mi occupo (per esempio col podcast “Ghiaccio sottile”) di crisi climatica, ma ho un approccio in evoluzione: non sono uno che fa funerali se muore un ghiacciaio, preferisco provare a vedere gli orizzonti che si vanno a creare, nella piena consapevolezza che la crisi climatica – il collasso – è un dato assodato e drammatico. Ma non voglio inibire la mia creatività, preferisco sospendere il giudizio e cogliere le variazioni del mondo in cui vivo. Le cose accadono, giuste o sbagliate che siano, molte sono sbagliate e spesso provocate da noi, però questo è. Anch’io mi sento assalito in estate, soffro tantissimo, siamo in 20mila sull’altopiano, in cinque paesi, che diventano 80mila per due mesi. Il 70% delle abitazioni sono seconde case, cosa faremmo però se anche solo il 30% venisse ad abitare qui? La soluzione va cercata e deve essere diversa in base al territorio al quale ci si riferisce.ù
Limitare l’accesso alla montagna ha senso per te?
Far pagare il parcheggio anche per poche ore a cifre senza senso, come in Val di Mello, per tutto l’anno, non serve a limitare il numero di presenze perché la gente ci va lo stesso. I piccoli comuni ne beneficiano, noi residenti molto meno, ci aspetteremmo tariffe separate, magari anche simboliche, visto che già paghiamo le tasse locali. Eviterei iniziative come l’apertura delle Cascate del Serio per cinque volte all’anno, visto che attirano migliaia di persone contemporaneamente, bloccando Valbondione per il traffico, un fatto spiacevole per tutti, turisti e residenti. Perché puntare tutto su poche iniziative molto congestionanti, per quanto utili ai piccoli comuni a non sentirsi “isolati”? Il Parco Adamello in Valle Camonica, per esempio, durante l’estate 2025 ha offerto 80 proposte spalmate nel tempo e nello spazio, tra le quali i cammini geopoetici della mia rassegna “Nei sentieri selvatici”. L’accesso alla montagna non può prescindere dal sentirne la fragilità, dal capire che può essere distrutta con progetti insostenibili (se non per pochi), come le Olimpiadi Invernali 2026. Serve una visione a lungo termine, quella che la politica tende a non avere. Quest’estate erano tutti a commentare le code al Seceda in Alto Adige, ma è un unicum, il problema va affrontato con uno sguardo a lungo termine, non sul singolo evento acchiappa click. Il tema di fondo resta la responsabilità personale, la capacità di darci dei limiti, di provare a ridurre il nostro impatto. Ma è un concetto verso cui la nostra società da anni non ci incoraggia più.