 Orso © Pixabay
Orso © PixabayUn nuovo fatto di cronaca, purtroppo dei peggiori, torna a scuotere l’opinione pubblica in merito alla gestione degli orsi e in generale dei grandi carnivori da parte delle autorità e della popolazione interessata. Pochi giorni fa un motociclista è stato attaccato e ucciso mentre percorreva la Transfagarasan, spettacolare strada nazionale della Romania, che per 92 km collega la Transilvania alla Muntenia, attraversando i Monti Faragus, la catena montuosa più alta del Paese. L’orsa è stata abbattuta il giorno stesso, i cuccioli dispersi (anche nella burocrazia). Neanche il tempo di raccapezzarsi che è avvenuto un altro “incontro” con un automobilista, stavolta privo di conseguenze, se non un grande spavento, sempre sulla stessa strada.
Considerata “la strada più bella del mondo”, con quei suoi panorami mozzafiato sulle selvagge foreste dei Carpazi, da ammirare mentre ci si inerpica su due o quattro ruote per stretti tornanti a U, la Transfagarasan è chiamata anche “Follia di Ceausescu”, perché fu il dittatore rumeno a farla costruire, fra il 1970 e il ’74, a colpi di dinamite: le ragioni non erano certamente turistiche, serviva una via di fuga rapida per le truppe in caso di invasione sovietica (ne sapevano qualcosa i cecoslovacchi, che nel ’68 si erano ritrovati i carrarmati a Praga).
Non tutti pensano che sia la più bella, ovviamente, ma di certo lo credeva il povero Omar Farangh Zin, 48enne della provincia di Varese, mentre si riprendeva con il cellulare, nella zona di Arefu, estasiato dal paesaggio, ma anche dai grossi orsi bruni a bordo strada, vicini a chi passa. Troppo vicini. “Per sperare nella coesistenza”, scrive Anna Sustersic nel libro Relazioni naturali (pp. 112, 14 euro, CAI Edizioni 2025), bisogna “tutelare l’in-coesistenza”. Se vogliamo convivere dobbiamo rimanere separati da un confine ben preciso, che è quello del bosco. Ma c’è di più: fatti come questo, e lo si è visto bene con l’uccisione di Andrea Papi, nel 2023 in Trentino, scatenano polemiche furibonde, più simili a quelle delle tifoserie calcistiche che a uno scambio di opinioni, per quanto acceso.
L’incontro con gli animali selvatici richiama in noi qualcosa di profondo e atavico: riaccende una memoria sopita che riporta a un passato in cui non eravamo i padroni del mondo. Duro da digerire per noi occidentali, ormai largamente scollegati dall’elemento naturale e in lotta non più per la nostra sopravvivenza fisica, ma per quella del nostro stile di vita. Sono molte le riflessioni al riguardo che emergono, nel dibattito pubblico odierno, strattonato fra i nostalgici del paradiso perduto e i pragmatici del consumismo estremo. In mezzo qualcuno cerca di capirci qualcosa, e anche di spiegarlo agli altri, come gli scienziati, i biologi, gli zoologi.
Di cosa parliamo davvero, quando parliamo di orsi? Abbiamo sentito proprio Anna Sustersic, triestina di nascita e trentina di adozione, che da anni si occupa di divulgazione scientifica e comunicazione ambientale (anche per La Rivista del CAI, dove cura la rubrica “Coesistenze”), testando su di sé per prima quelle paure e quel fascino che scatenano gi animali selvatici, temi affrontati nella sua ultima pubblicazione, il già citato Relazioni naturali.
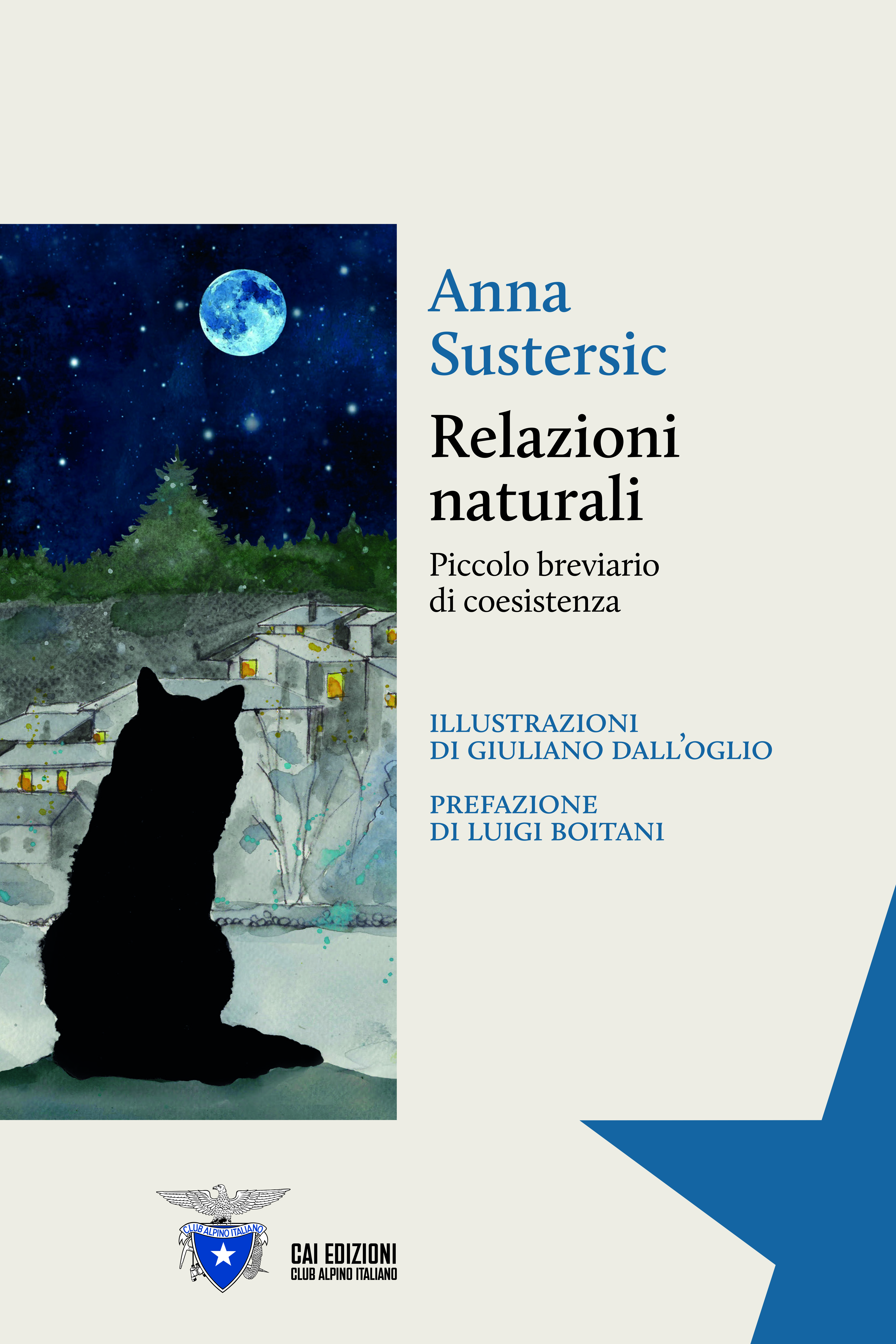 La copertina del libro
La copertina del libroAnna Sustersic, nel libro parli di Carpazi in almeno due capitoli, di cui uno intitolato “Wild Romania”, è così selvaggio quell’ambiente naturale?
La Romania è nota per essere la più grande area wilderness d’Europa, a causa dei grandi spazi non abitati e ancora sprovvisti di infrastrutture. Le strade che attraversano le montagne sono poche, anche quelle forestali che spesso non si spingono così a fondo nelle foreste, che si possono chiamare tali proprio in virtù della loro età, delle dimensioni delle piante e di un sottobosco molto strutturato.
Che differenza c’è rispetto al Trentino?
Quando parliamo di Wilderness intendiamo proprio grandi spazi non frequentati dall’uomo. Decisamente non il caso del Trentino. La Romania, a differenza delle montagne locali, non è ancora più di tanto strutturata per il turismo outdoor, e questo contribuisce ad avere buone parti di spazio interamente a disposizione della fauna, fra cui grandi carnivori come orsi (circa 8.000, anche se non ci sono ancora stime precise), circa 3000 lupi e 1500 linci. Io ci sono andata d’inverno, con la neve accompagnando un gruppo di ricercatori impegnati proprio in un progetto sulla lince. Il controllo delle fototrappole nel bosco era in totale freestyle, fuori sentiero perché i sentieri in quella zona non c’erano. Subito usciti dalla macchina e fatti i primi pass erano numerose le impronte di orsi (tante), lupi, linci e anche del gatto selvatico.
Nel capitolo “Selvatico andante” racconti che sono proprio queste impronte ad avervi indicato la strada, in mancanza d’altro ci si affida all’istinto degli animali per orientarsi.
Gli animali ottimizzano gli spostamenti (a parte la lince che da felino usa lo spazio in maniera particolare), di solito scelgono quelle più brevi e comode per andare da un punto all’altro. Nel nostro caso abbiamo seguito, per superare una cresta, quelle di un orso passato di recente, fidandoci del fatto che avesse optato per la via migliore. Naturalmente i ricercatori lì sanno bene come muoversi nel bosco, gli incontri sono frequenti e ci vuole un preciso codice di comportamento. Uno fra questi, in Romania dov’è legale, lo spray anti-orso che i ricercatori portano con sé più per i cani da guardiania, in realtà, che per gli orsi.
Eri per caso vicina alla zona dove è avvenuto l’incidente mortale dell’altro giorno?
No, mi trovano in una zona piuttosto distante dalla famosa strada dove è avvenuto l’incidente. In inverno quella strada è chiusa a causa del ghiaccio e della neve. Ma la sua notorietà, oltre alla bellezza e alla sua storia, è dovuta proprio agli orsi che sono una presenza costante lungo la strada, abituati dai numerosi automobilisti e motociclisti che gli danno da mangiare. A detta degli stessi rumeni, quella della “domesticazione” degli orsi, abituati al cibo dagli uomini, è un grandissimo problema nel Paese: la maggior parte degli incidenti che si verifica coinvolge proprio individui abituati a essere foraggiati dall’uomo e quindi più confidenti. Gli orsi della Transfagarsan sono in Romania una problematica forte.
Siamo in piena stagione escursionistica, è verosimile che si parlerà ancora di orsi.
Avvistamenti di orsi qui in Trentino in questi giorni sono piuttosto frequenti, quasi sempre nella zona del Brenta. Per questo è importantissimo ribadire le regole di ingaggio della coesistenza: la prima di tutte è non cercare di avvicinare gli animali, non dar da loro da mangiare, perché il principio cardine di tutta la coesistenza è proprio che il selvatico resti tale e in questo dobbiamo aiutarlo. La selvaticità è garanzia di diffidenza da parte degli animali che è a sua volta motivo di tranquillità per noi. Gli animali selvatici hanno paura dell’uomo, quindi il loro primo istinto è quello di scappare e noi dobbiamo metterli nelle condizioni di poterlo fare.
Cosa bisogna fare passeggiando in una zona di orsi?
È fondamentale manifestare la propria presenza: se si è in gruppo sono sufficienti le chiacchiere per far percepire agli animali la nostra presenza, se si è soli ogni tanto si può dire qualcosa a voce alta, piuttosto che battere i bastoncini, cioè dare modo per tempo agli animali di accorgersi che stiamo per passare e quindi di darsela a gambe, perché eventualmente è l’incontro a sorpresa che può creare il problema. Assolutamente evitare di avvicinarsi, o voler scattare foto da vicino: nella maggior parte dei casi gli animali scappano, ma un avvicinamento frainteso può sempre creare nervosismo.
E qui veniamo al nocciolo della coesistenza: il confine fra selvatico e antropico, da preservare come fondamentale.
Esattamente: non si tratta di crudeltà, ma anzi di un modo per tutelare tanto il selvatico, quanto le nostre attività. Bisogna programmare le nostre abitudini e il nostro comportamento per scoraggiare l’ingresso degli animali nei paesi o nelle città, che significa prendersi cura, per esempio, dei propri animali domestici, tenendoli al riparo soprattutto di notte, e non lasciare cibo o rifiuti fuori casa. Eliminare cioè tutto ciò che in un paese può risultare attrattivo per un selvatico, che sia una volpe o una faina – se non si vogliono perdere le galline – o animali come lupi e orsi.
Ci sono zone del mondo in cui questa consapevolezza è maggiore, come lo spieghi?
In paesi come la Slovenia e la Romania il rapporto con la fauna selvatica è più consolidato, o meglio ha una continuità diversa da quella che ha avuto da noi. Di certo pesa il fatto che la presenza di questi animali sia rimasta più o meno costante e non si sia interrotta per oltre un secolo come è successo da noi, ma anche il modello di sviluppo del territorio è diverso. Il Trentino si è da tempo vocato in maniera massiccia e capillare al turismo che è diventato la fondamentale fonte di economia. Slovenia e Romania hanno avuto percorsi di sviluppo economico decisamente differenti, dove la dimensione rurale si è mantenuta al punto da contribuire a mantenere un rapporto pragmatico e frequente con la natura.
L’incontro con il selvatico scatena polemiche furibonde che superano la mera cronaca. Evoca paura e fascinazione che tu stessa sperimenti e di cui parli nel libro. Quali sono le ragioni profonde di queste reazioni?
Il grande psicologo Aldo Carotenuto lo definiva “il fascino discreto dell’orrore”: lui aveva in mente ragni e serpenti, ma in parte vale anche per gli altri animali, specialmente quelli che al carattere di bellezza uniscono un senso di timore. Il mondo animale ci affascina e ci incuriosisce perché è un mondo totalmente altro, con codici comportamentali e regole diverse dalle nostre, eppure, in particolare nei mammiferi, ritroviamo caratteri di somiglianza. Certamente ci attira la bellezza del selvatico, di cui allo stesso tempo percepiamo il pericolo potenziale: un timore che richiama esperienze e istinti del nostro passato ancestrale. Una sfida antica che ha strutturato parti del nostro cervello addestrandole a rispondere e a creare strategie, una sfida che porta un disagio che ci siamo illusi di vincere eliminando questi animali. Ma il disagio resta perché è insito in tutto il selvatico e ci dobbiamo fare i conti, che si tratti di un’ape, di una zanzara, o di altri aspetti della natura. Ma la paura è certamente un aspetto indispensabile e fondamentale della nostra esistenza.
In che maniera la paura può diventare una risorsa?
La paura è come una sorta di palestra che mette in moto una formidabile serie di reazioni: già solo al pensiero dell’incontro, il nostro cervello si attiva, prefigura scenari, fa proiezioni, cerca le strategie concrete da adottare in caso di pericolo. E questo allenamento di sensi, ragionamenti e autocontrollo ci aiuta a diventare “esseri umani” in maniera più intensa.
Gli animali selvatici, insomma, e i grandi carnivori in particolare, ci ricordano che non abbiamo tutto sotto controllo… In una società a vocazione securitaria è difficile da accettare.
Ma questo resterebbe vero anche se scomparissero tutti i lupi e gli orsi del Pianeta! Quando in ballo c’è la Natura non siamo noi a poter decidere. L’unica cosa che possiamo fare è conoscerla al meglio, per adottare i comportamenti necessari a ridurne i rischi a cui la natura ci espone. Minimizzare e non eliminare, perché il rischio zero non esiste. Come quando siamo in macchina: guidare piano non è garanzia di sicurezza assoluta.